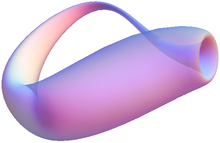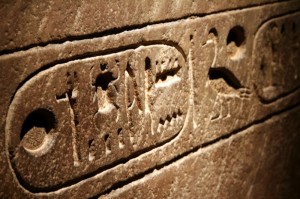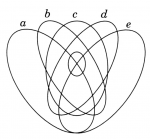Senza categoria
Fabrizio Gambini – Cosa fa sì che la psicoanalisi possa non essere un delirio?
Fabrizio Gambini
Cosa fa sì che la psicoanalisi possa non essere un delirio?
La leggenda tenta di spiegare l’inspiegabile. E dal momento che proviene da un fondo di verità, deve finire nuovamente nell’inspiegabile.
F. Kafka
Prima di tutto una questione: c’è, da qualche parte, qualcosa che garantisca che la psicoanalisi non sia un delirio, che non sia cioè una gigantesca e composita affabulazione che ha caratterizzato e segnato di sé la cultura e il modo di pensare degli uomini nel secolo trascorso? Se così fosse, ovvero se la nostra posizione fosse quella di più o meno seducenti o incomprensibili affabulatori, allora, oggi, la nostra posizione sarebbe quella di naufraghi attaccati alla loro zattera sgangherata in un oceano solcato da navi che combattono altre battaglie. Posizione scomoda ma tutto sommato comprensibile: a cosa volete che si aggrappi uno psicoanalista ultrasessantenne se non all’unico relitto galleggiante che ha a portata di mano? D’altronde sapete cosa succede ad uno psicotico che perde il suo delirio. Gli succede quel che è successo ad Aiace che, convinto di sterminare gli Atridi e i condottieri achei, al momento in cui perde il velo dell’illusione, siede quasi tranquillo, ma prostrato, in attesa di uccidersi.[1]…Questo significa che già sotto le mura di Troia si sapeva che là dove c’è caduta della paranoia attraverso la quale ci rappresentiamo il mondo, si apre per noi parlanti l’abisso della melanconia.
Dunque la questione diventa: c’è, da qualche parte, qualcosa che garantisca che non si sia aggrappati alla nostra scienza come un naufrago alla sua zattera? In effetti è così che molta letteratura ci vede e ci descrive. A me sembra però che, da qualche parte, qualcosa ci sia che garantisca l’esistenza del nucleo attorno al quale deliriamo. Perché sul fatto che si deliri, non c’è poi tanto dubbio. Unica consolazione è che, forse, non si può far altro che delirare, ovvero costruire. E, forse, c’è anche una gradazione nell’essere delirante di una costruzione. La costruzione che Lacan ci ha lasciato è, direi, la meno delirante che ci sia. La più delirante? Nella loro prosa limpida e onesta ce lo dicono Nicolas Abraham e Maria Torok nella loro analisi dell’analisi dell’Uomo dei lupi: Procedendo, non esiteremo, per comodità di esposizione, ad ipostatizzare i personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri: nomi che costituiranno la marca del loro stesso carattere xenomorfo e parassitario, tali da impedirci di confonderli con un “sé” clandestino.[2]
Questo testo si svilupperà in tre direzioni:
- Perché la costruzione che Lacan ci ha lasciato è la meno delirante che ci sia?
- Perché ipostatizzare dei personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri che costituiscano la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario, è delirare?
- Qual è, o dov’è, il nucleo attorno al quale, forse, non si può far altro che costruire, sperando di farlo il meno delirantemente possibile?
Prima di tentare di articolare qualcosa attorno alle domande che abbiamo posto, partiamo da dove tutto è cominciato:
Ci capita abbastanza frequentemente di non riuscire a suscitare nel paziente il ricordo del rimosso (Erinnerung des Verdrängten). In sua vece, se l’analisi è stata svolta correttamente, otteniamo in lui un sicuro convincimento circa l’esattezza della costruzione; ebbene, tale convincimento, sotto il profilo terapeutico, svolge la stessa funzione di un ricordo recuperato. Rimane da vedere (le indagini future daranno una risposta) in quali circostanze ciò accada, e come sia possibile che un sostituto (Ersatz) all’apparenza incompleto agisca cionondimeno con piena efficacia.[3]
E Freud prosegue notando che talvolta la comunicazione di una costruzione produceva l’affioramento di ricordi più che vividi (überdeutlich) che si sarebbero potuti chiamare allucinazioni se alla loro vividezza (Deutlichkeit) si fosse aggiunto il convincimento di una loro presenza (der Glaube an ihre Aktualität). A questo, continua Freud, si affianca talvolta la comparsa occasionale di autentiche allucinazioni in pazienti certamente non psicotici. Infine la conclusione: nel riconoscimento del nucleo di verità (Anerkennung des Wahrheitskerns) del delirio si troverebbe il punto d’incontro (gemeinsamen Boden) sul quale il lavoro terapeutico potrebbe svilupparsi.[4]
In questo stesso articolo, Freud non si limita a parlare, nel modo che abbiamo visto, e che dobbiamo ancora commentare, di costruzioni; si occupa anche, seppur molto brevemente, di ciò che resta dell’interpretazione che, in quanto tale, “si riferisce a ciò che si intraprende con un singolo elemento del materiale: un’idea improvvisa, un atto mancato e così via”.[5] Anche queste, come le costruzioni, fanno parte dell’analogia dalla quale Freud, e con ragione, è sedotto: le formazioni deliranti del malato gli sembrano l’equivalente delle costruzioni che gli analisti erigono durante i trattamenti dei loro pazienti.[6]
Non siamo solo nell’astratto e rarefatto mondo dell’epistemologia della psicoanalisi, al contrario. Se quanto dico ha un senso, tutto questo significa che è facile delirare, scivolare concretamente verso una struttura propriamente delirante di discorso. Chi tra noi lavora in ambito di neuropsichiatria infantile sa, ad esempio, con quanta facilità si può pensare, delirantemente, di inferire l’accaduto di un abuso da comportamenti infantili che vengono colti a partire da una costruzione che li identifica come segni dell’evento.
Allora, il nucleo di verità (Wahrheitskern)! In cosa consiste quest’espressione? Partiamo dal dire cosa non è: non è l’Es della seconda topica freudiana, non è l’Es di Groddeck[7] quello cioè di un’unità globale[8] a cui è supposto il fatto di viverci. In effetti il libro di Groddeck è interessante e Groddeck passa molto vicino a qualcosa che, a proposito del rischio di delirare, ci interessa molto:
Che impresa difficile parlare dell’inconscio! Si percuote a caso una corda e invece di una singola nota ne rispondono tante, che risuonano tutte insieme, confusamente, per poi ricadere nel silenzio, a meno che non risveglino nuove note, e sempre altre ancora, finché non ne risulta un rumoreggiare, un’incredibile confusione, in cui si perde il balbettio della parola. Mi creda, dell’inconscio non si può parlare, ma solo balbettare qualcosa, o meglio, si può solo piano piano accennare a questo o al quel particolare, se non si vuole che dal profondo emerga con clamore selvaggio la genia infernale dell’universo sotterraneo.[9]
In qualche modo si tratta della percezione che l’inconscio è strutturato come un linguaggio e che il riferimento al senso, al significato delle parole, si infrange contro il gioco del significante in una rete infinita di rimandi per i quali un’enunciazione che sia composta di un numero sufficiente di lettere, oltre a veicolare il proprio enunciato, non può non scomporsi in altre enunciazioni pur sempre veicolanti altri enunciati e dunque altri possibili significati. Senza limite. Groddeck è cosciente di questo al punto che, con una certa dose di ironia chiama il proprio ospedale Satanarium invece che Sanatorium.[10] Dichiaratamente l’intento della rivista che Groddeeck fonda nel 1918 è di dare voce alla “genia infernale dell’universo sotterraneo”:
Il Satanarium è il regno della menzogna. Il curatore è dell’opinione che solo le menzogne siano vere.
Egli, con ciò, apre porta e portone a ogni fantasia e prega i lettori di volere leggere in questa rivista delle verità, e non cercare in essa qualcosa che valga la pena di essere letto o addirittura qualcosa di istruttivo, vantaggioso, formativo. Poiché sul portale del Satanarium è scritto: Lasciate ogni logica.[11]
Quindi c’è un’estrema prudenza nell’affacciarsi sull’orlo dell’abisso ma, ovviamente, la prudenza va a braccetto col fascino altrettanto estremo che l’abisso esercita sull’autore del Libro dell’Es. Ora, chiunque abbia anche solo passeggiato in montagna sa che in certe circostanze la prudenza non impedisce scivolate dalle conseguenze anche potenzialmente tragiche. Difatti Groddeck di scivolate ne prende parecchie fino a reificare l’Es e farne un’entità globale, maligna e volitiva capace di strategie e di determinare la vita dell’individuo, il vissuto del corpo e scolpire nella materia del corpo i simboli che gli appartengono. Per non delirare ci vuole Lacan che ci dica che là dove Groddeck veda la materia è di “âme à tiers”[12]che si tratta. Ci torneremo. Per il momento restiamo a Groddeck e ai suoi scivoloni nel delirio. Ne cito uno, tratto dalla stessa lettera, la terza, che nella finzione letteraria del testo egli indirizza ad un’amica immaginaria, da cui è tratta la citazione in cui parla della genia infernale che abita l’universo sotterraneo dell’Es:
Lei trova esagerata la mia affermazione che le madri non sappiano quasi nulla dei loro bambini …[e sostiene che]…se c’è al mondo un sentimento di cui ci si può fidare, è proprio l’amore materno…Allora, vogliamo parlare un pochino dell’amore materno?…Basta soltanto osservare per ventiquattr’ore una madre che accudisce al suo bambino per notare in lei una certa dose di indifferenza, di fastidio, di odio: non c’è niente da fare, accanto all’amore per il bambino esiste in ogni madre anche l’avversione contro di lui. L’uomo è sottoposto a questa legge: dove c’è l’amore c’è anche l’odio, dove c’è il rispetto c’è anche il disprezzo, dove c’è l’ammirazione c’è anche l’invidia…Ne era a conoscenza?…Sapeva che questa legge vale anche per le madri?…L’inconscio conosce questo sentimento di odio…[e]…Le voglio mostrare in che modo si rivela nelle madri questa avversione, questo odio…la gravidanza, oltre che con l’assenza delle mestruazioni, si annuncia in modo molto sgradevole con nausee e vomito…La nausea è dovuta all’opposizione dell’Es contro qualcosa che si trova dentro l’organismo: nella nausea si esprime il desiderio di eliminare questo intruso, e il vomito è proprio un tentativo di espellerlo. Dunque desiderio e tentativo di aborto…In questa nausea si manifesta di nuovo l’idea che il seme del bambino entri nella donna attraverso la bocca, e a quest’idea allude anche l’altro sintomo concomitante della gravidanza, suscitato dall’ostilità contro il bambino, il mal di denti.
Attraverso le malattie dei denti l’Es intende [il corsivo è mio] dire, con la vocina tenue ma insistente dell’inconscio: “Non masticare: sta’ attento, sputa quello che vorresti mangiare!”. Ora, nel caso del mal di denti delle donne gravide l’avvelenamento ad opera del seme del marito è già avvenuto, ma forse l’inconscio spera di potersi ancora liberare di quel po’ di veleno incorporato, se non se ne aggiunge dell’altro. E in realtà l’Es cerca di uccidere il veleno vivente della fecondazione, e proprio attraverso il mal di denti: infatti (e qui riaffiora la totale mancanza di logica dell’Es, che mostra quanto sotto al pensiero razionale esso stia), l’inconscio identifica il bambino col dente. Per l’inconscio il dente è un bambino…il dente è figlio della bocca e la bocca è l’utero in cui esso cresce, proprio come il feto cresce nel corpo materno. Lei ammetterà che questi simboli devono essere ben radicati nella psiche umana, o come si spiegherebbero altrimenti le espressioni “labbra della vulva” e “labbra della vagina”?[13]
Inutile andare avanti con la citazione; il punto è ovviamente la conclusione a cui Groddeck giunge: l’uomo è alla mercé del simbolo e soggiace alle esigenze del suo destino inventando ciò cui lo costringe il processo di simbolizzazione. Per Groddeck, in realtà, noi siamo strumenti dell’Es, che fa di noi ciò che vuole. [14] Come vedete siamo in un delirio e del delirio, il discorso di Groddeck sull’Es, ha la progressione, la pervasività e il convincimento della presenza di ciò di cui si parla.
Quello di Groddeck è un modo di delirare che ha della caratteristiche precise, consistenti alla fin fine nel fatto che alla stessa costruzione viene attribuito, per riprendere l’esatta espressione freudiana, il carattere di corrispondere ad un nucleo stabile di verità (Wahrheitskerns). È questa la via attraverso la quale si costruisce una specie di dizionario dei simboli psicoanalitici, del genere: dente = bambino. Si tratta qui a mio modo di vedere dell’illusione di aver trovato un terreno anche solo minimamente solido quando siamo confrontati, come siamo confrontati, alla mancanza costitutiva del nostro essere parlanti: alla mancanza di rapporto sessuale che ci fa umani. Vale la pena di ricordare a questo punto quanto Freud avrebbe detto a Jung a proposito della sessualità:
Ho ancora vivo il ricordo di ciò che Freud mi disse: “Mio caro Jung, promettetemi di non abbandonare mai la teoria della sessualità. Questa è la cosa più importante. Vedete, dobbiamo farne un dogma, un incrollabile baluardo”. Me lo disse con passione, col tono di un padre che dica: “E promettimi solo questo, figlio mio, che andrai in chiesa tutte le domeniche!” Con una certa sorpresa gli chiesi: “Un baluardo contro che cosa?” Al che replicò: “Contro la nera marea di fango” e qui esitò un momento, poi aggiunse “dell’occultismo.” [15]
Ciò che Freud temeva a me sembra piuttosto chiaro e l’occultismo consiste proprio in quello che ho appena notato a proposito di Groddeck, ovvero nel dare consistenza di verità ai fantasmi che popolano le nostre rappresentazioni di ciò che chiamiamo inconscio.
Da questo punto di vista i già ricordati Nicolas Abraham e Maria Torok, nella loro analisi dell’analisi dell’Uomo dei lupi, sono chiarissimi: si tratta di ipostatizzare i personaggi interni che suppongono attivi nel Verbario dell’Uomo dei lupi. Sfortunatamente non dispongo dell’originale francese del testo che sono riuscito a consultare solo nella traduzione italiana, ma la cosa che trovo sorprendente è che i due autori usino loro stessi il termine “ipostatizzare”, termine del quale uno dei significati è: “trasformare arbitrariamente un’entità fittizia e accidentale come una parola, un concetto, in una vera e propria sostanza”. Dunque i personaggi interni che sono da loro supposti si trasformano da entità fittizie e accidentali in una vera e propria sostanza. Riprendo brevemente la frase che abbiamo citato in aperura di questo testo. I personaggi interni vengono ipostatizzati, conferendo loro dei nomi propri: Fratello e Sorella diventano Stanko e Tierka, mentre degli altri personaggi, bontà loro, mantengono il nome che indica la loro funzione, nobilitata da una maiuscola: Padre, Madre, Terapeuta. E aggiungono: i nomi attribuiti costituiranno la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario. Ora carattere xenomorfo mi pare significhi che la forma propria di questo carattere rivela la propria origine dall’esterno il che corrisponde esattamente, di nuovo, a quanto Freud osserva a proposito del delirio, delle allucinazioni e, in generale, delle formazioni psicotiche: quel che non può rappresentarsi all’interno si presenta all’esterno o, come lo articola Lacan, ma si tratta della stessissima cosa, quel che è forcluso nel Simbolico torna nel Reale. Qui però conviene restare a Freud e ai concetti di esterno e di interno perché è lì che si coglie l’aspetto delirante dei “nomi attribuiti” relativamente al loro carattere xenomorfo. E, naturalmente, come è proprio di tutti i deliri, la costruzione di Abraham e Torok non si ferma lì, anzi prosegue con progressione infernale, ricordate Groddeck e “la genia infernale dell’universo sotterraneo”? Ciò che da la stura all’epifania delle criptonimie[16] è la scoperta di una “formula magica”: la scoperta dell’anglofonia infantile dell’Uomo dei lupi.[17] Di cosa si tratta?
Quando il piccolo Uomo dei lupi aveva poco più di tre anni, durante un’estate, fu lasciato a casa con la sorella e, per l’occasione, una governante inglese venne assunta per sorvegliare i bambini[18] e, poco dopo il ritorno dei genitori, l’inglese fu mandata via.[19] Questo è l’unico riferimento che si trova alla governante nel testo di Freud scritto nel 1914 ma nel 1927, tredici anni dopo l’articolo sull’Uomo dei lupi, lo stesso Freud pubblica l’articolo “Feticismo”[20].
Qui si parla di un giovanotto che aveva eretto a condizione feticista un certo sfavillio sul naso e che trovò sorprendente spiegazione nel fatto che il pz da piccolo, era vissuto in Inghilterra, ma poi, trasferitosi in Germania, aveva dimenticato quasi completamente la sua lingua madre. Il feticcio, che traeva origine dalla sua più tenera infanzia, non andava letto in tedesco bensì in inglese, lo “sfavillio sul naso” [in tedesco “Glanz af der Nase”] era in realtà un’occhiata al naso (glance = occhiata, sguardo)…[21]
Per Abraham e Torok, Freud, nell’articolo del 1927 si riferisce all’Uomo dei lupi e, sempre secondo loro, avrebbe impiegato tutto questo tempo per accorgersi che la governante del bambino era inglese e trarre da ciò delle “conclusioni decisive ancorché succinte”.[22]
Da questo punto in poi, ovvero dalla “scoperta”[23] e dall’intuizione dell’inglese come lingua criptica, Abrahama e Torok fanno riferimento non solo all’analisi condotta da Freud, ma a quella condotta da Ruth Mack Brunswick, a quella successiva condotta da Muriel Gardiner e agli scritti, e alle lettere di Sergius Pankejeff, ovvero allo stesso Uomo dei lupi. Ne risulta un infinito Verbario[24] infarcito di “criptonimie” e aperto allo svelamento di ciò che queste nasconderebbero a partire dalla possibilità di giocare almeno su tre lingue: l’inglese della bambinaia, che è anche la lingua in cui sono comparse le sue memorie e in cui sono state condotte le sue due analisi americane, il russo che è la sua lingua materna e il tedesco con cui ha condotto la sua analisi con Freud.
In questa sede do solo un esempio di come si procede col Verbario e con la decifrazione delle criptonimie partendo da un punto, più che saliente, celeberrimo: il “Sogno dei Lupi” e la sua interpretazione:
Il punto di partenza , per una lunga catena di associazioni, non fu “sognai” , ma la parola “finestra” (in russo Okno) che tornava più volte…tornando per l’ennesima volta alle associazioni riferite da Freud, ci parve improvvisamente strano che fosse stato proprio Wolfmann a proporre l’interpretazione: “finestra” (Okno) stava per “occhio”, in russo Oko, ovvero Oč, il suo radicale per le forme riflessive. Perché sognare finestra quando si sa già che vuol dire “occhio”?
Influenzati dall’idea delle nurse, provammo a prendere la parola tedesca Fenster in inglese: window. Non solo: fu in un Whitsunday (in una domenica di Pentecoste) che, nel 1925, si ripresentò il “sintomo nasale”[25]; probabilmente sotto la spinta del film The White Sister,[26] visto il medesimo giorno. Molto vicino all’anniversario di questa data – un Whitsunday del 1926 – Wolfmann spedì a Freud la famosa lettera che confermava l’età precoce in cui si sarebbe verificato il sogno che stiamo analizzando…Non conosciamo il russo. Riusciamo a malapena a sillabarne i termini del dizionario; tale disgrazia è anche la nostra fortuna in quanto possiamo seguire meglio le direzioni del nostro ascolto, senza farsi guidare dal flusso della lingua. Dunque, se la parola “finestra”, per SergeJ Wolfmann, significa “occhio”, è proprio questa parola che deve essere ascoltata…aprirsi. Ma, su che? Nel dizionario dopo Oko viene Očevidez = testimone oculare, e, più oltre, Očevidno = evidentemente, termine che appare anche nel nostro sogno. Očewindow! I conti cominciano a tornare. Si direbbe che c’è, “evidentemente”, un rapporto tra Oče e window; e vi sono buone opportunità che esso sia contenuto anche nella precedente associazione, Whitsunday, intesa come il giorno della testimonianza (witness) del figlio (son): Oče-Videz of the son = la testimonianza oculare del figlio…In russo “sognare” si dice Videt Son. In Videt risuona whit cioè witness, e in Son il sun di Whitsunday. Inoltre Videz significa testimonio e son (=sogno) è omofono di son = figlio. Vi è quindi una sorta di omonimia, da un lato, tra Videt Son = sognare, fare un sogno e Videt + Son, e dall’altro l’inglese witness = testimone e son = figlio. “Sognai che era notte”: “notte”, l’avverbio in russo è Noč’u; niente ci impedisce di intenderlo in inglese: not you ( = non voi ). Azzardiamo quindi l’ipotesi: the withness is the son, not you: cioè il testimone è il figlio, non (siete) voi.[27]
Non importa procedere oltre. Il meccanismo è lo stesso, per tutta l’analisi del sogno, fino a che i due autori si trovano in possesso del “testo originale di quell’insieme di pensieri che sono stati tradotti e trasformati nel sogno dei lupi”.[28]
Io penso che pensarsi “in possesso del testo originale di un sogno” sia un delirio, come era delirio l’accesso al nucleo di verità proprie all’Es di cui pensava di essere in possesso Groddeck. Sapete qual è la cosa interessante? È che, per fuggire al rischio di delirare come Groddeck, ovvero al rischio di pensare all’Es come “un’unità globale che vi vive”[29] e vi determina, si finisce per delirare seguendo qualcosa che Lacan ha inaugurato col suo discorso.[30]
Vedete bene qual è allora il problema che mi pongo e che vi pongo: se, senza Lacan, si rischia di delirare verso un reificazionismo psicologico che non è privo della possibilità di sfociare in un delirio, in una resa all’occultismo, la lezione di Lacan, se non digerita adeguatamente, rischia di sconfinare ugualmente in un delirio che fugge dall’idea di un’unità globale che per trovarsi disseminato in una infinita rete di rimandi e di connessioni in cui, delirando, si può circolare all’infinito. Faccio anche notare che se la resa all’occultismo caratterizza l’approccio reificante all’Es, un capitolo in appendice del Verbario è dedicato all’occulto dell’occultismo.[31] La lettura di questo testo conferma ancora una volta una notazione che abbiamo già fatto e che riguarda la pervasività dell’ottica interpretante quando declinata sotto forma di delirio, la sua caratteristica mancanza di limite.[32] Nel suo seminario Lacan si era in un certo senso sorpreso che Derrida avesse scritto un’introduzione entusiastica al libro di Abraham e Torok. Queste le sue parole:
C’è una cosa che, devo dire, mi sorprende ancora di più della diffusione…del mio insegnamento a qualcosa che è all’altro estremo dei raggruppamenti analitici e che si chiama Istituto di Psicoanalisi…è che qualcuno di cui non sapevo che fosse in analisi, e che sia in analisi è semplicemente una mia ipotesi, qualcuno che si chiama Jacques Derrida, abbia fatto una prefazione a questo Verbario. Ha fatto una prefazione assolutamente fervente, entusiasta nella quale a me pare di cogliere un brivido legato…non so con quale dei due analisti abbia a che fare…[33]
Lacan prosegue affermando ribadendo che il libro è un delirio, la dimostrazione di ciò che chiama un estremizzazione.[34]
Vediamo dunque un po’ più da vicino questa estremizzazione. L’ipotesi che faccio è che, in ultima analisi, essa consista in una forma di forclusione del Nome-del-Padre. Come tale il permanere, in forma certamente particolare, di questa funzione è quanto differenzia il Joyce di Finnegan’s Wake da un’insalata di parole, e il seminario che precede quello di cui qui parliamo è appunto quello che Lacan dedica alla lettura di Joyce ma è a proposito dell’Uomo dei lupi che Lacan ricorda di aver parlato di forclusione del Nome-del-Padre. Ne ha parlato ad esempio a proposito della piccola allucinazione del dito tagliato notando che appare nel reale qualcos’altro rispetto a ciò che il soggetto mette alla prova e ricerca, qualcos’altro rispetto a ciò verso cui il soggetto è condotto da quell’apparato di riflessione, di padronanza e di ricerca che il suo Io. Con tutto ciò che questo comporta di alienazione fondamentale.[35] Qui, a mio modo di vedere, in questo esempio di Verwerfung, l’aggettivo “fondamentale” e il sostantivo “alienazione” sono da prendere in tutto il loro peso. E questo, almeno così mi pare, ci riporta all’oggetto, alla sua imprescindibilità, alla sua materialità, alla sua fondamentalità e alla sua radicale alterità. Ci torneremo alla fine di questo scritto.
Inoltre c’è un altro aspetto che mi preme sottolineare e sottoporre alla vostra attenzione perché mi pare ugualmente un aspetto centrale: diversamente da Derrida e da Deleuze, Lacan non è un filosofo, è un medico. Io penso che in fondo sia qui che dobbiamo cercare ciò che differenzia la sua schizofrenia da quella di Deleuze[36] e la sua ricerca dall’idea di decostruzione per via di disseminazione a cui approda Derrida. Detto in altre parole, il suo modo di Lacan di stare con i piedi per terra, il suo tentativo riuscito di non delirare per eccesso di senso senza cominciare a delirare per mancanza di senso in nome dell’infinite connessioni offerte dal gioco del significante e dal reale della lettera, è un modo che domanda una sorta di continuo appello al padre. Non si tratta neanche lontanamente dal padre immaginario del romanzo biografico, del padre reale che ha inciso in modo che dire non si può o del padre simbolico che affonda le sue radici nel parricidio primordiale e nella nascita della legge. Si tratta di una funzione che abbiamo molto indagato ma che ancora resta da indagare nelle sue più recenti trasformazioni.
Per continuare a farlo riprendo, una alla volta, le tre questioni attorno alle quali si attorciglia questo testo:
- Perché la costruzione che Lacan ci ha lasciato è la meno delirante che ci sia?
Provo a formularla meglio: cosa possiamo identificare nel discorso di Lacan che pone un limite, mette i bastoni tra le ruote alla nostra tendenza ad affezionarci alle nostre stesse costruzioni, a crederle, a pensare di saperle, come se il sapere riguardasse l’oggetto piuttosto che il soggetto, a reificarle, a spingersi fino alla loro ipostatizzazione? Naturalmente lo si potrebbe dire in molti modi. Tra questi ne scelgo uno che abbiamo già incontrato e sul quale ci tocca di ritornare:
Si vorrebbe identificare il reale con la materia. Io proporrei di scriverla piuttosto così “l’âme à tiers”. Questo sarebbe un modo più serio di riferirsi a questo qualcosa con cui abbiamo a che fare, e che non per niente diciamo omogeneo agli altri due.[37]
Questo qualcosa necessiterebbe, sono sempre le parole di Lacan d’un certo tipo di rapporti logici e, per essere precisi dei rapporti basati su una logica ternaria piuttosto che binaria.[38] Qui, per binaria io non capisco digitale, come il sistema binario di numerazione. La logica che è giudicata inappropriata ad affrontare la materia, ad affrontare il reale in cui si cerca di farla consistere, è la logica duale dell’Io/tu, del soggetto inteso come individuo che opera sull’oggetto inteso stolidamente e resistentemente passivo. Lacan ricorda che lo stesso Peirce era sorpreso che il linguaggio non esprimesse la relazione tra le sue parti., che non ci fossero rapporti stabili e costanti tra i suoi elementi, che non si potesse mai dire: avendo x un certo tipo, e non un altro, di relazione con y.[39] Capite che questo significa che ogni parte, che ogni lucuzione, che ogni sintagma che ogni monade di linguaggio comunque vogliate chiamarla è libera di rapportarsi, o meglio di mancare di rapportarsi, a tutte le altre. Vi ricorda qualcosa? Non è la libertà senza confini e senza scopo di un tappo di sughero che galleggia? Non è la macchina infernale di cui parla e che teme Groddeck? Con Lacan la materia di cui si tratta è altra cosa e domanda di essere trattata diversamente. La nostra materia è pur sempre quella di cui siamo fatti assieme noi e i nostri sogni, senza confini, senza cesure e senza ripartizioni,[40] ma è anche una materia il cui reale scopriamo omogeneo, indistinguibile dall’immaginario e dal simbolico che ce lo rendono percepibile. Non trovate che sia appropriata la dizione di “l’âme à tiers”? Non trovate che sia un modo di dire qualcosa di ciò con cui abbiamo a che fare che ci rende più difficile le operazioni di reificazione, di ipostatizzazione e, in fondo, di delirio?
- Perché ipostatizzare dei personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri che costituiscano la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario, è delirare?
In gran parte abbiamo già risposto ma vale la pena di riprenderlo. Se Abraham e Torok hanno il coraggio di fare scientemente questa operazione e scelgono di procedere a partire da elementi che hanno in sé, dalla loro ipostatica nascita, alcuni caratteri propri alle formazioni deliranti e allucinatorie, il più delle volte questo avviene senza che se ne abbia una precisa coscienza. Mi è capitato di assistere in televisione ad un dibattito tra due esponenti del mondo “psi”; almeno uno dei due era ampiamente riconosciuto dal punto di vista accademico e da quello psicoanalitico. Discutevano a proposito di un personaggio pubblico allora piuttosto in auge e, oggetto del contendere, era se il personaggio in questione, fosse affetto da un patologico narcisismo che ne condizionava l’immarcescibile senso di superiorità o se pure fosse affetto da un’ipercompensazione di un complesso di inferiorità. Sono rimasto ad ascoltare affascinato e ho avuto l’impressione che pensassero seriamente di discutere di due tesi (ipotesi? ipostasi?) contrapposte. Si può arrivare a questo punto, se si possono cavalcare parole come destrieri in una battaglia immaginaria tra due. Tra due significa che da qualche parte ci sarebbe rapporto sessuale, le parole corrispondono a cose che nominano e nello spazio euclideo con cui immaginiamo l’inconscio, due cose diverse non possono occupare lo stesso spazio: il complesso d’inferiorità ipercompensato, qualunque cosa questo significhi, spiazza l’idea di un narcisismo tronfio e compiaciuto di sé. Siamo, ma forse non è necessario dirlo, nella cattiva letteratura applicata alla psicoanalisi. Avere a che fare con la messa in piano di formazioni topologicamente diverse e distinguibili tra loro, aiuta ad uscire dallo spazio euclideo costruito dalla nostra mente a partire dall’immaginario corporeo. Ricordate che ad un certo punto della citazione che abbiamo posto all’inizio di questo scritto, Freud ipotizza la possibilità di un lavoro terapeutico che si fondi sul il punto d’incontro (gemeinsamen Boden) costituito dal riconoscimento del nucleo di verità (Anerkennung des Wahrheitskerns) del delirio. Leggete bene questa frase, gemeinsamen Boden è tradotto come punto d’incontro ma in realtà Boden significa “terreno” e gemainsam significa “comune”. Ebbene, questo terreno comune non è quello della rappresentazione spazializzata che a partire dall’imaginario corporeo abbiamo della mente, piuttosto è del terreno di cui la messa in piano delle rappresentazioni topologiche ci consente l’esplorazione che si tratta. Un’ultima cosa: mi ha molto colpito la parola “xenomorfo” che Abraham e Torok usano a ragion veduta. Che la loro ragione di usarla sia del tutto diversa dalla mia non ha nessuna importanza, è comunque a ragion veduta che viene usata. Per me la parola “xenomorfo” ha delle implicazioni terribili che, tutto sommato, penso si possano considerare a partire dal fatto che il prefisso “xeno” radica e perverte la nozione di Altro nella nozione di straniero, di radicalmente alieno. Come non far notare a questo proposito che il soggetto si costituisce come scisso proprio a partire dall’esistenza del significante della mancanza dell’Altro? Ovvero che non è di uno straniero che si tratta, di un alieno infernale. Ricordate Groddeck e la sua immagine? Al contrario, è proprio l’Altro e la sua mancanza che ci costituisce nel più intimo della nostra esistenza di parlanti. Con il linguaggio, essendo parlanti, parlando noi abbaiamo dietro a questa cosa, abbaiamo dietro a questo S di A barrato che noi siamo perché S di A barrato è questo: è il fatto che ciò che siamo e dietro a cui abbaiamo, non risponde.[41]
- Qual è, o dov’è, il nucleo attorno al quale, forse, non si può far altro che costruire, sperando di farlo il meno delirantemente possibile?
Eccoci infine alla cosa, al nucleo di verità, al Wahrheitskern. Se c’è, se si rappresenta, sa fa la sua comparsa, allora siamo nel delirio, oppure, se ciò che si presenta è il significante privato del significato che sarebbe fondamentale per noi, siamo nell’afanisi soggettiva e, infine se si presenta sotto le spoglie del fantasma che lo realizza, siamo nella nevrosi. In tutti i casi si tratta dell’oggetto, ma penso che sia chiaro a tutti la situazione in cui ci veniamo a trovare. E non è una bella situazione. Se c’è, c’è su fondo d’angoscia, ed è il delirio, o l’allucinazione in cui l’oggetto a ex-siste in quanto, forcluso nel simbolico torna, nel reale. Non sempre ex-siste come tale, talvolta ciò che si presenta è un significante che non rappresenta il soggetto per un altro significante. La mancanza di questo secondo significante per il quale il soggetto si trova non essere rappresentato dalla comparsa del significante che lo determinerebbe, comporta l’afanisi del soggetto, la sua scomparsa, il suo totale sprofondamento.[42] Infine, lo ripeto, ed è la terza e ultima possibilità, il soggetto si rapporta alla sua rappresentazione dell’oggetto, al suo fantasma. Siamo dunque nella nostra nevrosi che, in quanto tale, ci preclude l’accesso al nucleo di verità di cui stiamo parlando.
Sapete qual è la nostra salvezza? Cos’è ciò che ci permette, di lavorare, amare e produrre, stretti come siamo tra follia e stupidità?[43] Ebbene, è il fatto che l’oggetto a, lo stesso oggetto che rende folli o stupidi, è anche causa di desiderio. Dunque ci muove, e che qualcuno, un analista, sia disposto ad incarnarlo, a farne la sua posizione nella conduzione di una cura, permette a questo movimento di cercare e, in qualche caso, perfino di trovare una qualche forma di accomodazione. C’è un godimento in questa posizione? C’è un godimento nell’esercitare la propria funzione di analista? Sarebbe auspicabile di no, anzi è decisamente auspicabile di no. Qui non vedo altra possibilità di godimento che un godimento perverso, come tale causa di sciagure per l’analizzante che si trova ad essere l’oggetto causa del desiderio del suo analista. Resta il desiderio ma è una formulazione che non mi ha mai convinto fino in fondo, non ho mai capito bene cosa significhi e, direi, che anche Lacan non doveva avere le idee troppo chiare in proposito se ha proposto e in seguito lasciato cadere, come tutti noi abbiamo poi lasciato cadere, la procedura della passe.[44]
Per conto mio non riesco ad andare oltre a quel che Lacan dice di Freud:
…Freud, non aveva niente di trascendentale, era un povero medico, che, mio Dio, faceva quel che poteva per ciò che si chiama guarire, il che non va tanto lontano…[45]
e che penso si possa applicare a Lacan stesso come forse ad ognuno di noi, il che ci riporta a non essere filosofi e forse a dover essere giustamente terrorizzati dalla filosofia in effetti,[46] dagli effetti della filosofia tradotta in pratica. Diversamente da Deleuze e Guattari, non possiamo permetterci un anti-Edipo. Esplicitamente, in anni a noi più vicini, Pier Aldo Rovatti si pone la questione se la filosofia possa curare,[47] e scrive:
Lui [il curando] chiederà benefici, qualcosa che lenisca le sue paure, infine un aiuto terapeutico, se pure di una terapia “pulita” e per niente medicalizzata. Tuttavia il cosiddetto consulente, se avrà guadagnato una qualche consapvolezza critica della cultura terapeutica in cui oggi siamo, non dovrebbe fornirgli alcuna consolazione. Anzi, si troverà nella condizione di smontare o decostruire [rieccoci a Deleuze, Derrida e compagnia decostruendo] pazientemente le sue attese, in vista – forse – di un nuovo scenario in cui parole come “rischio” e “spaesamento” dovrebbero funzionare, piuttosto che come sinonimi di un disagio, cioè di qualcosa da curare, come aperture di esperienza, cioè – paradossalmente – come la cura stessa o un suo primo affacciarsi. D’altronde, quando mai la filosofia ha accettato se stessa come qualcosa di normalizzante? Bisognerà pur ricordarsi che se chiami a casa tua un “filosofo” che sia degno di questo nome (ma qui sta il punto), ti sei messo in casa un insetto fastidioso che di mestiere punge, e non un qualche servitore del potere.[48]
Che non possiamo permetterci un anti-Edipo, significa per me che non ci possiamo sottrare alla nostra responsabilità, e cerco di spiegare perché. Se è vero, come è vero che, essendo parlanti, noi abbaiamo dietro all’Altro che non risponde, è però anche vero che abbiamo inventato Dio padre che, col suo silenzio, a qualcosa risponde; consentendoci così di continuare a domandare. Detto in altre parole, è la funzione del Nome-del-Padre che ci costituisce come desideranti di fronte all’impossibile. Che la psicoanalisi si trasmetta, è questo che la costituisce come riferimento ad un ordine dentro il quale ci si inscrive ed è questo che consente il maneggiamento di una funzione che non sia solo quella di un insetto fastidioso. Freud andava al di là del fastidio, parlava di portare la peste, ma ne parlava a Jung. Come dire che solo un’appartenenza comune, il riferimento ad un’origine e ad una fondazione comune consente di temperare la tensione filolitica propria al discorso della psicoanalisi. Dunque niente anti-Edipo per quanto mi riguarda. Piuttosto si tratta di articolare qualcosa rispetto alla funzione del Nome-del.Padre che non si costituisca come un appello nostalgico, un richiamo al buon tempo andato. In un mio scritto recente[49] ho posto la questione se qualcosa di questo genere non lo si possa trovare a partire dall’apologia della legge che Socrate fa nel Critone. Per Socrate non si tratta di difendere ciò da cui una legge è supposta originare, il suo, diciamo così, imperativo. Socrate difende la legge in quanto è la legge che fonda la città nel discorso ed è la città che fonda la parola nell’individuo. Pensiero circolare? Sì, certamente, ma sono in buona compagnia, tra Dante Alighieri[50] e Lacan che per quarantotto ore si è sfinito, senza successo, a fare quella che chiama una quatreccia, ovvero una treccia a quattro capi.[51] Tre capi, è chiaro che cosa siano e come si intreccino in modo borromeo: reale, simbolico e immaginario. C’è poi un quarto capo, il sintomo. Se dobbiamo pensare al simbolico come al significante, in quest’occasione il significato è un sintomo (il quarto capo) e il corpo, ovvero l’immaginario, è distinto dal significato. Questo modo di fare la catena (la quatreccia) comporta inoltre che il reale sarebbe specialmente appeso, avrebbe dei rapporti privilegiati col corpo. Da questo risulterebbe che in qualche modo il reale si continuerebbe nell’immaginario. Tralascio qui le costruzioni e i disegni che Lcan produce. Basta riferirsi al seminario per seguirne lo sviluppo. Quello che mi interessa è il rapporto che questo discorso ha con Socrate, con la circolarità del pensiero e la necessità di inscriversi in una tradizione, ovvero il rapporto che il sintomo ha a sua volta con la funzione del Nome-del-Padre. Il reale non è la materia; l’abbiamo detto, è l’âme à tiers per questo presa nel suo intreccio col simbolico e con l’immaginario; in particolare questo reale si continua nell’immaginario del corpo, senza soluzione di continuità. Pensate alle psicosomatosi, alle conversioni, ai disturbi della cenestesi, ai deliri ipocondriaci e avete l’immediata percezione di cosa questo significhi. Ma è ovvio che una conversione non si fa solo nella continuità tra immaginario del corpo e reale. Perché qualcosa si converta è necessaria la presenza di un significante, ovvero del simbolico: se gli esseri umani possono sentire un “groppo in gola” è ben perché esiste sia la parola “groppo” che la parola “gola”. Dunque terzo anello. Ma neanche questo basta. Affinché invece di dire “groppo in gola” si senta un “groppo in gola” in rapporto alla parola che qualcuno pronuncia davanti a noi, è necessario un sintomo, è necessario che quella parola, pronunciata in quel momento, abbia per noi un significato. È qui che si ritrova la funzione del Nome-del-Padre. Essere esposti alla castrazione simbolica, significa accedere ad un senso unico per noi, piuttosto che essere psicoticamente presi nel senso che abbiamo per l’Altro materno e significa anche accedere ad un senso unico per noi, piuttosto che essere nell’angoscia della comparsa dell’oggetto a che ci viene a ricordare il nostro essere senza senso. Dunque il sintomo, il quarto anello, il quarto capo della quatreccia.
È Lacan, si certo è Lacan, ma è anche Freud quando ci riporta a delle considerazioni fondamentali del genere che lo sviluppo dell’umanità, il suo così detto progresso, non è dovuto alla ricerca del bene comune, o allo sviluppo di una scienza del reale che di per sé sarebbe foriera di conquiste sempre maggiori; il nostro sviluppo è dovuto invece al sintomo, al nostro far massa attorno al sintomo.
Allora, per concludere, si può praticare la psicoanalisi senza delirare? Forse no, ma, nello stesso tempo, la psicoanalisi può non essere un delirio. Basta che ad essa ci teniamo come al nostro sintomo, alla nostra tradizione, alla nostra appartenenza sapendo che, come è per la legge difesa da Socrate, non si basa su niente se non sull’uso che possiamo farne.
[1]il luogo pieno di strage cominciò a distinguere, battendosi le tempie diede un grido. E là, stroncato fra corpi stroncati, giacque sul sangue degli agnelli, e a forza d’unghie e di dita segava e strappava i suoi capelli, e senza più parole stette gran tempo…In triste stato, senza né cibo né bevanda, l’uomo tra le belanti uccise dalla spada, siede quasi tranquillo, ma prostrato. E già tende si vede, a triste meta. Quale sia la “triste meta” è noto: Aiace si getta sulla propria spada, infissa al suolo, uccidendosi. Sofocle, Aiace, 350 – 358 e 370 – 275.
[2] N. Abraham e M. Torok, Il verbario dell’uomo dei lupi, tr. it. Liguori, 1992, p. 115.
[3] S. Freud, “Costruzioni nell’analisi”, in Opere (OSF), Boringhieri 1979, vol. 11, p. 549.
[4] Ivi, pp. 550 e segg.
[5] Ivi, p 545.
[6] Ivi, p. 552.
[7] G. Groddeck, Il libro dell’Es, tr. it., Mondadori 1971.
[8] Cfr. J. Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, Séminaire 1976 -1977, pubblicazione fuori commercio, lezione IV, p. 54.
[9] G.Groddeck (1971), cit., p. 34.
[10] G. Groddeck, Satanarium, tr. it., Il Saggiatore 1996.
[11] G. Groddeck (1996), p. 15.
[12] Il gioco si fa tramite l’omofonia di “la matière” e, appunto, “l’âme à tiers.” J. Lacan. cit., (1977) p. 51.
[13] G. Groddeck (1971) pp. 29-36.
[14] Ivi, p. 107
[15] C. G. Jung, Ricordi sogni riflessioni, Il Saggiatore, Milano 1965 p. 191. A questo proposto cfr anche il modo in cui lo stesso punto, e la stessa citazione, è ripreso in F. Gambini, Paranoie. Tra psichiatria e psicoanalisi: saperci fare con la psicosi, Franco Angeli, Milano 2015, p. 85.
[16] Nella traduzione italiana è scomparso dal titolo il riferimento alle “Cryptonimie”. È tanto più sorprendente in quanto proprio il riferimento alla cripta, alla criptazione e alla “decifrazione” costituisce l’asse portante della prefazione di Derrida al libro di cui stiamo parlando e il cui titolo, nell’originale francese, è il seguente: Cryptonimie. Le Vérbier de l’Homme aux Loups.
[17] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 102.
[18] S. Freud, “Dalla storia di una nevrosi infantile”, in Racconti analitici, Einaudi 2011, p. 685.
[19] Ivi, p. 686.
[20] OSF, vol. 10, p. 491.
[21] Ibidem.
[22] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 102.
[23] Ibidem.
[24] Si tratta ovviamente di un neologismo, ricalcato sul neologismo francese Verbier. In entrambe le lingue si tratta di parole raccolte come si raccolgono le erbe in un erbario e analizzate a partire dal senso supposto che è loro supposto
[25] Il naso torna molte volte, nella verruca della madre come nel sogno del naso adunco del padre. Il fatto sostanziale è che ad un certo punto della sua vita Pankejeff temeva di soffrire per un Lupus (sic!) seborroico al naso.
[26] White è bianco come bianchi sono i lupi del celeberrimo sogno e dalla sua analisi, così come condotta da Freud, risulta l’implicazione della sorella (Sister) nella genesi del sogno.
[27] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 150 – 152.
[28] Ivi, p. 158
[29] Cfr. Lacan, cit. (1977) p. 54.
[30] …ce qui m’a un peu effrayé dans ce qui chemine, en somme, de quelque chose que j’ai inauguré par mon discours. J. Lacan, cit. (1977) p. 52.
[31] Torok M. L’occulto dell’occultismo, in Abraham N. e Torok M., cit. p. 225.
[32] La questione del limite merita un commento a lato del testo di questo articolo. Se da un lato possiamo pensare all’ermeneutica come ad una teoria dell’interpretazione che nascerebbe solo in epoca moderna, dopo la Riforma, in conseguenza dell’Umanesimo e dell’Illuminismo e che si caratterizzerebbe essenzialmente per la sua autonomia, secolarità e universalità (P.C. Bori, L’interpretazione infinita, Il Mulino, 1987, p. 6) dall’altro quella interpretativa è un’esperienza i cui presupposti sono remoti e in un certo senso universali e che assume speciale chiarezza nella lettura cristiana della Bibbia. Questa lettura, ai suoi inizi, si trovò dinanzi a speciali difficoltà: l’autorità delle scritture giudaiche era infatti indiscussa e al tempo stesso tuttavia la loro distanza, la loro alterità era non solo implicita, ma direttamente denunciata da una parte degli scritti neotestamentari. Questo dualismo portava da un lato al continuo rischio della rottura con le radici giudaiche […] dall’altro ad un singolare affinamento della lettura allegorica, affinamento consistente nel non negare o svalutare il senso storico, e nel dispiegare orizzontalmente la polisemia…(P.C. Bori, cit. p. 7). A questo si deve aggiungere quanto è proprio della mistica ebraica ovvero un pensiero che ricorre in tutta la letteratura rabbinica, fin dagli esordi, e che identifica il grande libro della Torah, con la sapienza di Dio. La Torah è considerata preesistente alla formazione del mondo e racchiude pertanto non solo il racconto della genesi, delle vicende storiche del genere umano e dei precetti che regolano la vita d’Israele, ma anche il progetto stesso della creazione. (G. Busi, Mistica ebraica, Einaudi 1995, p.VII). Da qui a concepire uno sviluppo delirante delle “criptonimie” bibliche il passo è breve. Per esempio questo: La storia comincia con la descrizione dei fatti. Questo libro è la prima descrizione d’un codice incluso nella Bibbia che rivela accadimenti sopraggiunti migliaia d’anni dopo che la Bibbia è stata scritta. Dunque si tratta, forse, della prima descrizione dell’avvenire. Abbiamo appena cominciato a comprendere il codice della Bibbia. Questa assomiglia ad un puzzle composto da un numero infinito di pezzi, di cui non ne possediamo che poche centinaia. Possiamo solo immaginare il risultato finale. Tutto quello che posso assicurare è che c’è un codice nella Bibbia e che, in qualche caso spettacolare predice degli avvenimenti che si sono prodotti esattamente nel modo in cui sono stati descritti. (M. Drosnin, La Bible: code secret, tr. fr., Laffont 1997. La traduzione italiana del testo è mia.) Tanto perché si capisca bene di cosa parlo, cito un po’ a caso dal libro cosa si è potuto desumere dall’interpretazione del codice: l’assassinio di Rabin, l’olocausto, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, la scrittura di Amleto da parte di Shakespeare, la formulazione della teoria della Relatività da parte di Einstein, etc.
[33] J. Lacan, cit. (1977) p. 53.
[34] Ibidem.
[35] J. Lacan, Les Psychoses, le Séminaire, Livre III, Seuil 1981, p. 98.
[36] Cfr. Deleuze e Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. Einaudi, 1975.
[37] J. Lacan, cit. (1977) p. 51.
[38] Ibidem.
[39] Ivi, p. 52
[40] …We are such stuff / As dreams are made on, and our little life / Is rounded with a sleep…(W. Shakespeare, The Tempest, atto IV, scena I).
[41] J. Lacan, cit. (1977), p. 54.
[42] Ivi, p. 74.
[43] Ivi, p. 54.
[44] Nella lezione dell’8 febbraio Lacan lascia la parola ad Alain Didier Weill e lui, prima di cominciare a parlare: “Posso dire che parlerò della passe?”. E la risposta di Lacan: “Può anche parlare della passe.” J. Lacan, cit. (1977), p. 69
[45] Ivi, p. 48.
[46] Ibidem.
[47] P. A. Rovatti, La filosofia può curare?, Cortina, Milano 2006.
[48] Ivi, p. 22-23
[49] F. Gambini, “Il Nome-del-Padre: una versione italiana”, in Bergasse, 19, numero 12,Torino 2014.
[50] Abbiamo detto prima che l’uomo parlò rispondendo…Dante, De vulgari eloquentia, Libro I, IV, 5.
[51] J. Lacan, cit. (1977), p. 55.
7 novembre, Roma – introduzione al seminario di J. Lacan L’insu que sait…
Conferenza di M. Darmon e P.-Ch. Cathelineau sul seminario di Jacques Lacan L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-1977)
dove: via Carlo Fea 2, nella sede del Dipartimento di Slavistica, al I° piano dell’edificio di Villa Mirafiori
quando: sabato 7 novembre ore 11.00
per informazioni rivolgersi a: info@lacanlab.it
sabato 15 marzo, Roma – Il fenomeno psicosomatico
Laboratorio Freudiano di Roma
Elisabeth Du Boucher Lasry – Ecole Sigmund Freud di Parigi
Silvana Fiorito – immunologa
Anna Molino – ginecologa
Chiara Rusconi – pediatra
dove: via Corsini 3, Roma
quando: sabato 15 marzo dalle 10 alle 18
Fabrizio Gambini – Perseguitare il persecutore
Fabrizio Gambini
Perseguitare il persecutore
ovvero
Cosa ne è della Paranoia nella società dell’immagine?
Saggio per un’analisi topologica di una forma di psicosi nella Nuova Economia Psichica
Nell’interlocuzione tra l’Io e un’allucinazione non è mai questione di simmetria. Non c’è alcuna forma di simmetria tra l’Io stesso e l’oggetto che si presenta come allucinazione. È un altro modo per dire quel che Freud già notava, ovvero che l’oggetto, quando si presenta, è presente su uno sfondo d’angoscia. L’angoscia accompagna sempre una percezione il cui tratto fondante è la mancanza di simmetria rispetto all’Io per cui si produce.
È questo l’incubo della materializzazione del doppio: l’immagine speculare che ci corrisponde, col braccio sinistro che gratta lo stesso naso che noi grattiamo col destro, cessa di essere speculare, si anima di un’anima che non è la nostra, e smette di corrisponderci. A ben vedere non è neanche sicuro che si tratti dello stesso naso perché, ad esempio, nel caso che sul naso si abbia un neo sulla narice destra, l’immagine corrispondente mostra un naso fornito di neo a sinistra. La simmetria è in fondo la garanzia di un ordine che fa sì che il mondo che vediamo corrisponda ordinatamente a ciò che supponiamo ci sia lì dove qualcosa vediamo. Si tratta della simmetria fondamentale che costituisce la garanzia della relazione biunivoca e simmetrica tra ciò che è impresso sulla retina come immagine e quanto c’è nel mondo la cui immagine ci rappresentiamo. Ma quando l’immagine in sé si anima? Quando si rende cioè indipendente e si mette lei, l’immagine, ad esistere? Allora la simmetria costitutiva del nostro mondo si rompe e la mancanza di simmetria che caratterizza l’insorgenza del doppio genera angoscia. Da questa angoscia, a protezione dall’angoscia stessa, si genera l’idea del persecutore. È quello che succede al personaggio di Gogol che si trova perseguitato dal proprio naso, è quello che succede al personaggio della fiaba di Andersen che si trova perseguitato e condannato a morte dalla propria ombra, è quello che avviene al Dr Jekyll perseguitato dall’odioso Hyde, ed è quello che avviene a Tertuliano Máximo Afonso per aver noleggiato una videocassetta. In sostanza è quello che sempre avviene nel momento in cui la fantasia dei romanzieri evoca l’incontro impossibile col doppio.[1]
Il doppio infatti è quanto ci corrisponde, senza però corrispondere per questo all’immagine che noi ci facciamo del mondo. A prima vista non tutti gli oggetti che ci corrispondono e animano un Reale diverso dalla nostra realtà, sembrerebbero avere la caratteristica di essere “doppio”, ma, a ben vedere, c’è qualcosa che spinge comunque in questa direzione. Che dire, ad esempio, del Dio che parla all’Io dal luogo della forclusione dell’istanza paterna? Il Dio della psicosi, in qualche modo, è sì un doppio dell’istanza paterna,[2] ma un doppio che non possiamo riconoscere come tale, non avendo accesso all’originale così duplicato. Il risultato è che la percezione allucinatoria compare, come si è detto, su sfondo d’angoscia. Evidentemente il rapporto tra Io e Dio è altra cosa del rapporto tra Io ed Io[3]: il Dio che parla allo psicotico è un altro Dio da quello che l’Io si rappresenta come oggetto della fede che sceglie di testimoniare. Siamo un po’ nella situazione evocata da quella barzelletta, puntualmente e acutamente segnalatami dalla persona alla quale avevo accennato, per discuterne, il contenuto di questo scritto, e nella quale un signore si trova totalmente solo in cima ad una montagna e di fronte ad un panorama grandioso. Si guarda intorno, guarda in alto, e comincia a gridare: “C’è qualcuno?” Sempre più angosciato e inquieto, grida sempre più forte, fin quando una voce dal cielo risponde “Dimmi figlio mio”. “Chi sei?” interroga l’uomo, e la voce risponde “Io sono Dio”. “E come faccio a saperlo?” interroga di nuovo l’uomo. “Gettati nel vuoto affinché i miei angeli ti possano raccogliere e portarti da me” risponde serena la voce. L’uomo, incerto, si guarda un po’ intorno e grida: “C’è qualcun altro?”
Il punto fondamentale dunque è che quello che ci corrisponde nel registro della psicosi, ad esempio le allucinazioni che noi produciamo, non ci corrisponde nel registro immaginario, e per questo simmetrico, in cui l’Io riconosce il mondo e riconosce se stesso. Per questo, ripeto, l’insorgenza dell’oggetto nel nostro campo percettivo avviene e non può che avvenire su sfondo d’angoscia.
Non è l’unica caratteristica dell’oggetto. Ad esempio ce n’è una seconda che è quella della reciprocità. Ma la reciprocità non è la simmetria. Da un oggetto orale si può essere mangiati, da ciò che vediamo possiamo essere visti ma, ripeto, questa reciprocità non è simmetria e, non essendo simmetria, non è in grado di proteggerci dall’angoscia. Che dire, ad esempio, di una madre che dica al proprio bambino: “Ti mangerei di baci”? La fonte di nutrimento si fa divoratrice. Dove collocare un amore del quale si è oggetto e in nome del quale si può essere nutriti, vezzeggiati e, nello stesso tempo, divorati?
Non saprei citare l’autore o il titolo, ma ricordo perfettamente un breve racconto di fantascienza in cui una specie di postino spaziale naufraga con la propria astronave su un pianeta sconosciuto e lì si imbatte in un enorme animale simile ad una pantera. Della pantera l’animale ha il corpo, i peli, la bocca, le zanne e gli artigli, ma non ha gli occhi né il naso né le orecchie. La testa assomiglia piuttosto ad una grossa palla di pelo il cui aspetto è tale da far pensare che l’animale voglia aggredire e divorare l’uomo. Nel suo cercare di sfuggire all’animale, l’uomo si chiede con quali sensi l’animale lo individui, per capire come nascondersi: sottrarsi allo sguardo su o dietro un albero, sottrarsi all’olfatto rotolandosi nella terra o immergendosi nell’acqua, sottrarsi all’udito restando in assoluto silenzio? Come sfuggire a chi ti segue senza occhi per vedere, orecchie per sentire e naso per annusare?[4] In forma romanzata è la questione che Lacan pone nel seminario sull’angoscia quando evoca l’immagine di una mantide religiosa nel cui occhio prismatico non ci si può specchiare. Non sappiamo cosa e chi siamo per lei che, insieme, ci ama e ci divora. È da questa forma d’angoscia che la simmetria dell’immagine ci protegge: occhio per occhio, dente per dente, punto per punto. L’allucinazione, il ritorno dell’oggetto nel reale, pur essendo preso nella reciprocità, manca di questa simmetria, e per questo genera angoscia.
Un modo per proteggerci dall’angoscia generata da questa specifica mancanza di simmetria, senza per questo sprofondare in un rapporto puramente immaginario tra l’Io ed il suo Tu speculare che, in quanto tale, non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io, è il riconoscimento della funzione della differenza sessuale. Molto banalmente, questo significa potersi inscrivere, ad opera della castrazione, in una soggettività sessuata.
Vale la pena, a questo punto, di fare una piccola digressione, circa le modalità con le quali il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge dal presentarsi dell’oggetto in quanto fonte d’angoscia. Di questo si hanno tracce imponenti quanto evidenti: ho visto recentemente un adolescente precipitato in una crisi di panico dal pensiero che forse era all’inizio di una relazione d’amore, e di sesso, con una compagna di scuola. Se la relazione non è col simile, con lo speculare, col simmetrico e, per questo, col prevedibile, la relazione stessa diventa fonte d’angoscia: per salvarsi, ha dovuto fuggire, come il postino spaziale o come davanti ad una mantide religiosa. Ci torneremo più avanti in questo scritto.
In ogni caso, in generale, il nostro strutturale sentimentalismo ci porta a pensare che là dove c’è sesso, possa eventualmente esserci anche amore. Talvolta ci spingiamo addirittura a pensare il sesso come conseguenza sciagurata della caduta dell’amore e al ritorno all’amore come guarigione dal sesso. Per introdurre invece il punto centrale di quel che intendo con la nozione di ineliminabilità della presenza della divisione sessuale per quanto riguarda la protezione dall’angoscia, vorrei provare a rovesciare la frase nel modo seguente: là dove c’è amore siamo sicuri che, se le vanno come devono andare, c’è sesso; ovvero è il sesso che consentirebbe una sorta di guarigione dall’amore, che ne consentirebbe, diciamo così, un esercizio temperato. Si tratta di una proposizione che, a ben vedere, è decisamente fastidiosa e, direi, poco digeribile ai più.
Finché la questione riguarda un uomo e una donna siamo tranquilli, ben installati nel nostro senso comune come in una pantofola: sesso e amore appaiono poter andare di pari passo, sesso accompagnato dal dono dell’amore o amore dal quale, completandolo, il sesso ci protegge. Ma la stessa proposizione (là dove c’è amore c’è sesso) può ugualmente riguardare due uomini o due donne, così come riguarda madri, padri, figli e figlie, e come riguarda la relazione che ognuno di noi ha con il prossimo, del quale ci dicono che andrebbe amato come amiamo noi stessi. La frase riguarda dunque anche la relazione che abbiamo con noi stessi e, infine, riguarda l’amore degli amori, il modello di ogni amore, ovvero l’amore che l’essere umano ha per Dio e il suo reciproco: l’amore che l’uomo suppone a Dio nei suoi confronti.
Quando dico che quello per Dio è il modello di ogni amore, intendo qualcosa di molto preciso, ovvero che è modello di ogni amore perché è amore nella sua forma pura, nella sua forma perfettamente soggettiva, in quanto rivolto a ciò che non c’è: amore per ciò che non esiste. Il punto è che questa forma di assenza dell’oggetto è caratteristica di ogni forma d’amore e, ripeto, è per questo che l’amore per Dio è il modello di ogni forma d’amore. L’oggetto d’amore non c’è, come non c’è Beatrice per Dante, Laura per Petrarca e Silvia per Leopardi. Tutt’e tre, Beatrice, Laura e Silvia, hanno dovuto non esserci per poter esistere per sempre per ognuno di noi in quanto trasfigurate dall’amore di uno di noi.
L’amore è amore dell’assenza, è amore della mancanza. L’amore è nostalgia, è lontananza. Lo celebra una vecchia canzone di Domenico Modugno: “La lontananza sai è come il vento…” che non ricordo esattamente cosa faccia ma che, in sostanza, trasforma in incendi i fuocherelli, e lo celebra una celebre immagine di Levinas, che metaforizza l’incontro con l’altro come una carezza, ovvero un gesto pudico di ritiro e di allontanamento.
Ora, il sesso è precisamente ciò che istituisce la mancanza che, quando funziona come si deve, genera carezze, ovvero amore.
Questo vuol dire, ad esempio, che c’è divisione sessuale tra una madre e suo figlio e, se c’è divisione sessuale, è fondamentale che ci sia riconoscimento della stessa e che, conseguentemente, possa esserci la sua simbolizzazione, ovvero il suo farsi parola. Forse è necessario ricordare a questo punto la psicoanalisi e l’accusa di pansessualismo che a questa è stata e continua ad essere rivolta. Su questo, sull’importanza della teoria sessuale per Freud, ci sarebbe da interrogarsi al lungo[5], per il momento limitiamoci ad osservare che una madre che abbia parole per nominare la distanza, che l’accetti come costitutiva della relazione, potrà volere il bene di suo figlio senza per questo volere la perfetta corrispondenza tra il figlio e l’oggetto immaginato come necessario al compimento del suo ben-essere di madre. Pensate all’amore di Maria per Gesù, amato come figlio e “lasciato” libero di morire in croce per compiere qualcosa che riteneva parte necessaria del suo percorso. Ma, molto più in piccolo, penso alla madre di un mio paziente, un omone di 120 kili del quale la madre è riuscita a dire: “Lei lo sa dottore, per me N. è come un figlio”. Chi assisteva con me al colloquio l’ha preso come una sorta di lapsus con il quale si prendeva una certa distanza dalla maternità e dalla responsabilità della stessa. È strano, ma io l’ho presa al contrario: avere un figlio può succedere; succede alle leonesse e alle tigri come alle donne, ma che N. fosse come un figlio, implica una scelta, un rafforzamento, un raddoppiamento[6] e una conferma solo umana del legame biologico. Ovvero ho letto in quel “come”, la cifra di un disconoscimento, di un mancato riconoscimento della differenza sessuale che separasse l’omone da ciò che era per sua mamma.[7]
Al contrario, il riconoscimento della differenza sessuale, questa introduzione nella dialettica io – tu di una differenza che, ripeto, è sessuale, impedisce lo svolgersi di un rapporto sterile, a prodotto zero, puramente immaginario tra l’Io e il suo Tu speculare, che non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io.
È da questo che il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge. Più in generale non si tratta solo di protezione dalla psicosi, ma anche del fatto che, ad opera del riconoscimento della differenza, siamo protetti dalla contingenza moderna che vede il trionfo dell’immaginario e l’annegamento del desiderio nella concupiscenza dell’oggetto di consumo.
In questo contesto l’altra metà dell’androgino, la metà perduta, non sarebbe, diciamo così, l’altra metà della mela, bensì l’immagine speculare dell’unica metà che, in quanto immagine, sostiene l’illusione dell’esistenza della mela in quanto intero. Ne consegue che la sessualità è ciò che consente a tutte le mezze mele che siamo di sopportare di essere divise e, insieme, di avere a che fare con altre mezze mele, anche loro auspicabilmente sopportanti di essere mezze. [8]
Sappiamo bene che è per questa ragione che nella psicosi, caratterizzata da una peculiare difficoltà di accesso alla castrazione, resta la traccia di una difficoltà nel riconoscimento della differenza tra i sessi. Freud direbbe che resta la traccia della fondamentale bisessualità dell’essere umano, resta, in ogni caso, come una specie di ordito che soggiace alla tela in cui si rappresenta ogni forma unica, individuale e irripetibile di psicosi.
Anche nel caso del quale intendo parlare c’è una traccia di questo, e Barbara, puntualmente, narra di un passato “gravato” da difficili esperienze omosessuali. Adesso non ha una vita sessuale e il sesso sembra essere l’ultimo dei suoi problemi. La peculiarità di Barbara, la cifra della sua situazione psicopatologica, non sta però nella sua presunta omosessualità, bensì nel modo in cui Barbara nega la funzione della differenza nella relazione Io – Tu, interloquendo con un altro immaginario che non sarebbe nient’altro che lo specchio dell’Io, se non fosse che il gioco tra l’oggetto a e l’oggetto a1 fa comparire nello specchio l’oggetto, dando all’altro della relazione immaginaria la funzione di persecutore. In altre parole, il sintomo, piuttosto che operare come una sorta di raddoppiamento del simbolico, nel caso di Barbara, opera piuttosto come un raddoppiamento dell’immaginario, in un gioco tra a e a1 che esclude ogni rassicurante simmetria nello specchio dell’Io.
Partiamo, per provare a rappresentare questa situazione, dal gioco tra immaginario, reale e simbolico.
È un gioco che possiamo immaginare[9] attraverso un falso nodo a trifoglio: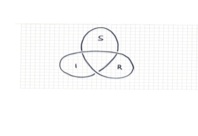
Qui, nel falso nodo a trifoglio, avremo che la separazione, e dunque la possibilità di funzionamento simultaneo R. S e I in quanto separati, è data soltanto dal ripiegamento del tratto orizzontale della corda verso l’alto e che niente impedisce al trifoglio di diventare un otto, e all’otto di diventare un cerchio, ovvero uno spazio in cui non è possibile alcuna articolazione tra R,S e I: quello che sarebbe una sorte di morte psichica, una resa totale alla schizofasia, al gioco totalmente anarchico e disarticolato tra lettera, significante e significato. Affinché questo falso nodo tenga, consentendo almeno una parvenza di psichismo, è dunque necessario ricorrere ad una seconda corda, che può essere posizionata in diversi punti:
Il primo (fig. 1) fissa l’incrocio in basso in modo da lasciare possibile in ogni momento la costruzione di un otto in cui S è separato dallo spazio comune di R e I. 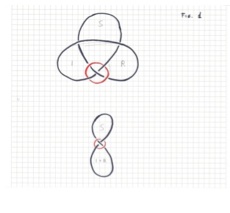
Il secondo (fig 2) fissa l’incrocio a sinistra in modo da consentire un otto in cui R è separato dallo spazio comune costituito dalla coincidenza di S e I: 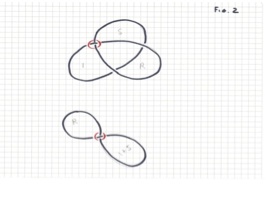
Il terzo infine fissa l’incrocio a destra in modo da rendere impossibile il disfacimento della forma a trifoglio (fig. 3) e dunque l’articolazione e separazione tra S, R e I.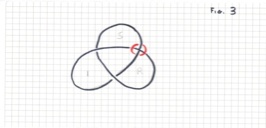
Direi che per Barbara qualcosa è successo che ha legato i tre registri nel modo indicato dalla figura 1, ovvero una sorta di forclusione del simbolico che lascia totalmente separato lo spazio comune al reale e all’immaginario. Il reale è quel che Barbara immagina che sia e, nella realtà, questo reale compare come un’ombra pervasiva, come un doppio strisciante che la getta nell’angoscia. Mancanza di simmetria, l’abbiamo detto, ma non mancanza di reciprocità e dunque l’odio per l’ombra crea l’odio da parte dell’interlocutore che da quest’ombra è investito. In altre parole, gli accidenti della sua vita, l’hanno portata ad annodare i registri all’incrocio di I e R (fig. 1). Questo significa che l’oggetto a si raddoppia immaginariamente in un oggetto a1 del quale non c’è modo di liberarsi e che non cessa di segnare, con la sua angosciante presenza, l’altro dell’interlocuzione immaginaria. Fermo restando quell’annodamento, si è prodotta una irrimediabile separazione tra S da un lato, e I ed R dall’altro. E anche questo è un modo per rappresentare qualcosa della forclusione del simbolico che costituisce il tratto propriamente paranoico di Barbara.
Il padre, professionalmente affermato, ha su di lei e sul suo corpo un potere di vita e di morte. Barbara ricorda, o meglio, pensa e teme di ricordare, un episodio un po’ confuso: lei bambina su un divano, qualcuno, forse un amico del padre, era seduto sullo stesso divano e delle carezze o un contatto le hanno fatto pensare che il padre, presente nella stanza, la offrisse quale oggetto di godimento sessuale alla concupiscenza dell’altro. Se dichiarava la sua difficoltà, se cercava aiuto, in questa come in molte altre circostanze successive, la domanda d’aiuto era bollata come malattia dal padre che, a causa del suo potere sociale e professionale, e intendo con questo il potere pressoché infinito che Barbara suppone al suo terrificante padre immaginario, trovava sempre chi ratificava questa sua diagnosi, impedendo così all’urlo di dolore di Barbara di essere altra cosa che una espressione sintomatica, scaturita come un fungo dal suo micelio dal luogo oscuro della follia di Barbara. Qui non si tratta di metafore. Al centro della questione si trova infatti la voce o, se preferite, l’orecchio che questa voce raccoglie. È l’orecchio/voce che, letteralmente, incarna per Barbara il persecutore. I vicini la odiano e la perseguitano perché odono le sue urla, e non si rendono conto che lamentandosi di queste, la spingono ad urlare sempre di più, in una spirale senza fine. Adora il telefono, è il suo strumento preferito. Quando mi parla, anche di persona, nei momenti in cui mima la voce dell’Altro (il padre, un vicino), la sua voce si arrochisce, si trasforma e si carica d’odio come una nuvola dell’acqua di un temporale. Lo stesso tono a tratti compare, non come mimesi dell’altro che la perseguita, bensì come effetto del suo rivolgersi a me, quando mi ingiuria. In questa circostanza è lei il persecutore che mi accusa di perseguitarla in quanto rappresentante di una psichiatria che non ha con lei altro rapporto se non quello determinato dal suo essere lo strumento coercitivo e violento della volontà persecutoria del padre. L’annodamento di Barbara si è fatto tra un padre immaginario e terrificante che minaccia, punisce ma che non istituisce una regola riconoscendo la quale si avrebbe diritto all’amore. La domanda d’amore, rivolta a quell’oggetto immaginario, diventa persecuzione, diventa stimolo alla punizione, all’esercizio della violenza. Quello di Barbara è un odio/amore che genera odio. Barbara diventa così una specie di stalker,[10] preda di una paranoia che ha la preoccupazione di costruire concretamente, nella realtà, il proprio persecutore, e lo fa nell’unico modo che conosce, perseguitandolo. D’altronde è l’odio che si situa alla giunzione tra immaginario e reale ed è lì che Barbara si è trovata a fare il suo annodamento. Il simbolico resta fuori campo, escluso dal tentativo di far coincidere la realtà col reale annodato all’immaginario.
Questa situazione domanda una particolare cura per essere maneggiata ed è una cura alla quale si deve sempre molta attenzione quando si tratta di maneggiamento di un transfert psicotico. Bisogna fare attenzione a che, nella gestione transferale di una situazione del genere di quella descritta, non si vada formando un annodamento di tipo 2 che vede l’immaginarizzazione di un padre simbolico a scapito di una specie di “forclusione” del Reale che non ne consente alcuna caduta. Barbara mi parla di un precedente terapeuta, morto, che lui sì che aveva capito, che lui sì sarebbe stato in grado, che lui sì avrebbe potuto antagonizzare il padre. Ciò a cui bisogna fare attenzione è di non trovarsi mai nella posizione del terapeuta morto, ovvero di chi “lui sì”. È una posizione che apre fatalmente a reazioni terapeutiche negative. Il reale non metabolizzabile di questa immaginarizzazione di un transfert simbolico, ritorna sempre e ritorna con la carica di odio che puntualmente si presenta alla giunzione tra reale e immaginario.
Eppure si tratta di provare ad operare uno spostamento del nodo dalla posizione in cui il legame tra immaginario e reale forclude il simbolico (fig. 1), ma si tratta di spostarlo verso il legame tra simbolico e reale che, come si vede dall’immagine del nodo, non “forclude” nessuno dei tre registri, bensì li tiene annodati in modo che questi possano funzionare all’unisono ma separati tra loro.
Ora, per forzare il transfert a costruire questo tipo di quarto anello (fig. 3) non è che ci siano molti modi, anzi, sempre più, con l’avanzare della mia esperienza nel trattamento di quadri psicotici gravi, mi pare che il modo sia uno solo ed è quello di far valere, in un certo modo, la funzione del “no”.[11]
Il “no” di cui si tratta è un “no” al quale un agente sia supponibile. Questo significa che quel “no” non sarà un puro Reale che, a rigor di termini, renderebbe letteralmente non esistente l’oggetto negato, e che non sarà neanche il riflesso di una posizione immaginaria (fin troppo facilmente percepibile come contrap-posizione) attribuita all’altro che detta la sua legge violenta e arbitraria. Piuttosto il “no” che andiamo ricercando è la funzione di un limite percepito come il riflesso di un po’ di Simbolico, del poco Simbolico che il soggetto può avvicinare, avvicinandosi così, nella misura del possibile per lui, a qualcosa che sarebbe vagamente dell’ordine della castrazione.
Quello di cui parliamo è un “no” non sempre facile da maneggiare, in particolare si tratta di evitare l’immaginarizzazione di un’istanza paterna, forclusa nel simbolico, che rischia di tornare nel reale senza alcuna possibilità di essere articolata, se non come allucinazione o idea delirante. È quel che è successo a Schreber con Flechsig ed è quello che in effetti succede spesso col risultato di esporre il paziente ed il suo terapeuta a reazioni terapeutiche negative o a delle impasses irrisolvibili della cura. La ricetta per evitare che questo succeda è apparentemente semplice anche se il tentativo di capire che cosa questa significhi in concreto ci occuperà per un po’ di tempo. Per il momento la formulerei nel modo seguente: temperare col riferimento al reale la funzione immaginaria della quale si è transferalmente investiti, al fine di consentirne una parziale simbolizzazione.
In prima istanza, prima di addentrarci nei percorsi clinici che possono illustrare questa posizione, vorrei riprendere alcune questione relative agli annodamenti possibili dei tre registri.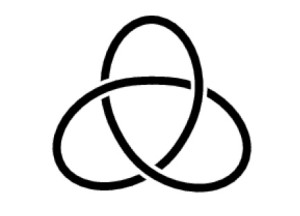 Questo è un nodo a trifoglio che, in quanto tale, definisce quattro spazi. Questi sono costituiti da uno spazio centrale formato dalla confluenza dei tre spazi laterali. Se indichiamo questi ultimi con R,S e I al centro avremo uno spazio che è R + S + I. Si tratta di un vero nodo, ovvero di un intreccio che non si può sciogliere a meno di non interrompere la continuità della corda che ce lo fa immaginare. Non è un osservazione banale; significa che non diventa psicotico chiunque lo voglia. Al contrario, bisogna che questo tipo di annodamento sia fallito, perché qualcosa del funzionamento inconscio possa manifestarsi “a cielo aperto” ovvero secondo una modalità appunto psicotica.
Questo è un nodo a trifoglio che, in quanto tale, definisce quattro spazi. Questi sono costituiti da uno spazio centrale formato dalla confluenza dei tre spazi laterali. Se indichiamo questi ultimi con R,S e I al centro avremo uno spazio che è R + S + I. Si tratta di un vero nodo, ovvero di un intreccio che non si può sciogliere a meno di non interrompere la continuità della corda che ce lo fa immaginare. Non è un osservazione banale; significa che non diventa psicotico chiunque lo voglia. Al contrario, bisogna che questo tipo di annodamento sia fallito, perché qualcosa del funzionamento inconscio possa manifestarsi “a cielo aperto” ovvero secondo una modalità appunto psicotica.
In ogni caso, in questo tipo di annodamento, siamo presi in un funzionamento psichico che si confronta con oggetti investiti di un loro valore reale, simbolico e immaginario, e dunque posizionati nello spazio centrale, ma, nello stesso tempo, la nozione di simbolico, di reale e di immaginario, risulta istituita per il soggetto che in questo modo può scomporre l’oggetto nel proprio discorso, pur salvaguardandone l’unità in quanto oggetto causa del proprio desiderio.
Ho già accennato al fatto che recentemente è venuto a consultarmi un ragazzo adolescente: bravo ragazzo, ottimo studente, impegnato in lodevoli attività extrascolastiche, di aspetto piacevole. Cos’è che non va? Ha conosciuto una ragazza, ha pensato che avrebbe potuto conoscerla meglio, ha avuto l’impressione che la ragazza non fosse restia ad approfondire la conoscenza, si sono scambiati un bacio e gli è esplosa una crisi d’angoscia per la quale ha “dovuto” troncare immediatamente la relazione appena nata. Si chiede che senso abbia la vita ed erotizza l’idea della morte volontaria come presa d’atto dell’insensatezza di tutto. È spaventato da questa erotizzazione, la teme come teme l’amore, e fugge dai suoi pensieri come è fuggito dalla nascente relazione d’amore. Tutti quelli con cui ha parlato fino a quando è venuto a consultarmi (genitori, amici, insegnanti) gli hanno dato delle risposte banalizzanti che, ognuna a suo modo, sono tutte caratterizzate dal non tener conto dell’esistenza del nodo. Un amico gli dice: “Non capisco tutto ‘sto casino per una ragazza, se ci sta te la fai, poi che te ne frega?”, i genitori si angosciano della sua angoscia e lo hanno accolto nel lettone tra mamma e papà, un professore gli rimanda che le questioni filosofiche sono legittime, ma che quando risuonano con quel livello di coinvolgimento personale forse c’è qualcosa che non va e bisognerebbe forse vedere uno psicologo.
Non è che abbia dovuto fare molto, semplicemente tenere una posizione che, in sé, dichiara un certo numero cose. Per esempio queste: i pensieri possono essere pensati, quando ci sono non c’è che da assumerli e vedere di che si tratta; non ci sono pensieri “sbagliati”, ci sono pensieri pensati male. Se i pensieri hanno difficoltà ad essere pensati, il fatto di lasciarli parlare, di lasciare che si facciano parola concretamente articolata nel discorso che si fa voce parlante, aiuta a poterli pensare e, eventualmente, a trovare un modo nuovo per poterli pensare. In questa impresa non è da solo: la sua funzione di analizzante è contenuta da quella d’un analista posato, tranquillo e con la barba bianca, che ascolta ciò a cui succede di farsi parola come l’ascolta il ragazzo stesso. Circolando così il discorso, gli aspetti di simbolizzazione, di decostruzione dell’immaginario, e di impasses con le quali si tocca con mano l’esistenza d’un reale, trovano, o possono trovare, una loro articolazione. Il risultato è che ha conosciuto un’altra ragazza, le ha suonato una sera al campanello di casa facendole una specie di sorpresa, la vede spesso e me ne parla. Senza angoscia.
Altra cosa è quando ci troviamo di fronte ad una sintomatologia psicotica. Anche qui, per cominciare ad articolare qualcosa attorno a questo tipo di funzionamento è utile tornare a riferirsi a un possibile sviluppo del nodo a trifoglio. Questa volta siamo di fronte ad un “falso nodo”, ovvero niente impedisce ai due falsi nodi (A e B) di trasformarsi in un “otto” (A può trasformarsi in C e E, mentre B può trasformarsi in D e F) e niente impedisce all’otto di trasformarsi in un cerchio, ovvero in un totale indifferenziato di simbolico, reale e immaginario. Per evitare che questo succeda, per evitare in qualche modo quella specie di morte psichica che è la totale indifferenziazione, è possibile che dei nodi si facciano in punti diversi, ovvero a partire dalle diverse sovrapposizioni a cui da luogo il “falso nodo” a trifoglio.
Questa volta siamo di fronte ad un “falso nodo”, ovvero niente impedisce ai due falsi nodi (A e B) di trasformarsi in un “otto” (A può trasformarsi in C e E, mentre B può trasformarsi in D e F) e niente impedisce all’otto di trasformarsi in un cerchio, ovvero in un totale indifferenziato di simbolico, reale e immaginario. Per evitare che questo succeda, per evitare in qualche modo quella specie di morte psichica che è la totale indifferenziazione, è possibile che dei nodi si facciano in punti diversi, ovvero a partire dalle diverse sovrapposizioni a cui da luogo il “falso nodo” a trifoglio.
Se il nodo si fa alla sovrapposizione di R e I abbiamo due figure simili nel senso che S risulta separato dallo spazio creato dalla confluenza di R e I. La differenza riguarda il punto di sovrapposizione. Nella configurazione A possiamo dire che I sormonta R e l’inverso succede nella configurazione B in cui è R che sormonta I. Ciò con cui ci troviamo ad avere a che fare è che le configurazioni C e D sono l’una l’immagine speculare dell’altra.
Se il nodo si fa alla sovrapposizione di R e S abbiamo due situazioni diverse a seconda se l’annodamento si faccia nel falso nodo caratterizzato da R che sormonta I (fig. B) o in quello caratterizzato da I che sormonta R (fig. A). Nel secondo caso (fig.A) avremo un otto che vede da un lato lo spazio di I e, dall’altro lato del nodo, lo spazio dato dalla confluenza di S e R (fig. E). In questo caso il quarto anello, affinché il nodo tenga, passerà sopra I, sotto I, sopra R + S e poi, prima di chiudersi ad anello, sotto R + S. Nel primo caso (fig.B), diversamente dal caso precedente e poiché e R è sovrapposto a I (fig. B), quando andiamo ad annodare S e R, ci troviamo che a tenere in quanto nodo, è l’insieme del trifoglio più il quarto anello (fig. H). Lo stesso succede se, a partire dal “falso nodo” in cui I sormonta R (fig. A) annodiamo S e I (fig. G). La questione interessante è che questa figura (G) è l’immagine speculare di quella che abbiamo descritto prima (H). lo è ma non lo è del tutto, in quanto nel gioco dello specchio, se S si trova in alto in entrambe le immagini, R e I sono invertiti, mentre il quarto anello, che lega S e I nell’immagine G, lega invece R e S nell’immagine H. Resta che, se sottraiamo dall’immagine quel che differenzia gli spazi non in termini di forma, bensì in termini di contenuto (R,S e I), l’immagine H è speculare rispetto a G.
Infine, se annodiamo S e I quando R sormonta I, otteniamo di nuovo un otto in cui R risulterà separato dalla confluenza di S e I e in cui il quarto anello sormonta e poi passa sotto R per sormontare in seguito S e I prima di passargli sotto per chiudere il nodo (fig. F). Qui la situazione è ancora diversa in quanto, se restiamo all’immagine senza specificazione dei tre registri, la figura F non è speculare, bensì identica alla figura E.
Per quanto riguarda la psicosi, partiamo dall’osservare che le figure C e D metaforizzano in qualche modo l’idea che il tratto caratteristico della psicosi è la forclusione di qualcosa di simbolico. Questo significa che il funzionamento del Nome-del-Padre è stato tale da non consentire l’accesso al simbolico tramite il divieto che barra l’accesso all’oggetto, e questo comporta la possibilità che l’oggetto ritorni nel reale in quanto delirio o in quanto allucinazione, ovvero come immagine, acustica, visiva. tattile o eidetica, poco importa in questa sede. Tutto sta nella particolarità dell’annodamento che la specifica articolazione dell’istanza paterna ha consentito di operare. In entrambi i casi (C e D) l’annodamento si è fatto tra un simbolico “puro” e un’istanza paterna capace solo di legare il simbolico alla consistenza comune di R e I. Questo significa che appena noi tiriamo un po’ sul nodo ci troviamo a constatare che il doppio incrocio tra S e l’anello rosso che fa tenuta (una volta passa sopra e una volta passa sotto) è solo apparentemente doppio in quanto, tirando leggermente sulle due corde, l’incrocio diventa uno solo, ovvero è in un solo punto che S incrocia l’anello rosso. 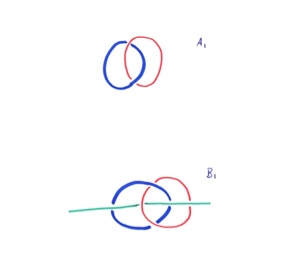 Siamo insomma nella figura A1, dove basta tirare a sinistra il blu e a destra il rosso per verificare che i due cerchi si toccano in un solo punto. Affinché la sovrapposizione resti doppia, ovvero per fare in modo che una volta il blu passi sopra il rosso e una volta passi sotto, bisogna inserire una terza consistenza (fig. B1) che impedisca lo scivolamento del blu sul rosso e viceversa. È questo doppio incrocio che comporta per il soggetto la possibilità di sostenere la doppiezza costitutiva del significante e dunque, in qualche modo, la propria scissione soggettiva. Se manca una terza consistenza succede, come ho detto poc’anzi, che l’annodamento si fa tra un simbolico “puro” e un’istanza paterna capace solo di legare il simbolico alla consistenza comune di R e I. Nell’unico punto d’incrocio non c’è possibilità di articolazione significante, non c’è doppio passaggio bensì passaggio singolo. La parola è la cosa: psicosi, appunto.
Siamo insomma nella figura A1, dove basta tirare a sinistra il blu e a destra il rosso per verificare che i due cerchi si toccano in un solo punto. Affinché la sovrapposizione resti doppia, ovvero per fare in modo che una volta il blu passi sopra il rosso e una volta passi sotto, bisogna inserire una terza consistenza (fig. B1) che impedisca lo scivolamento del blu sul rosso e viceversa. È questo doppio incrocio che comporta per il soggetto la possibilità di sostenere la doppiezza costitutiva del significante e dunque, in qualche modo, la propria scissione soggettiva. Se manca una terza consistenza succede, come ho detto poc’anzi, che l’annodamento si fa tra un simbolico “puro” e un’istanza paterna capace solo di legare il simbolico alla consistenza comune di R e I. Nell’unico punto d’incrocio non c’è possibilità di articolazione significante, non c’è doppio passaggio bensì passaggio singolo. La parola è la cosa: psicosi, appunto.
Allora, per riprendere il filo della direzione di una cura di psicosi, si tratta di facilitare, attraverso il maneggiamento del transfert, un annodamento che consenta la tenuta del nodo. Questo significa legare S e I quando R passa sotto I e legare R e S quando R passa sopra I. In questo modo, legando S e R si ottiene che l’anello I sarà impedito a scovolare via dal nodo dal fatto che la consistenza che lo separa da S e R gli passa una volta sopra e una volta sotto (fig. H) e che, legando invece S e I, l’anello R sarà impedito a scivolare via dal nodo dal fatto che la consistenza che lo separa da S e I gli passa ugualmente una volta sopra e una volta sotto.
Chiuso con i nodi. Voglio solo esplicitare bene a cosa è servito questo lungo passaggio in un campo di veri e falsi trifogli, partendo dalla fine, ovvero dall’ultima annotazione riguardante il fatto che è una terza consistenza che impedisce a due anelli legati tra loro di scivolare reciprocamente fino a congiungersi in un solo punto. Si tratta di un’immagine che rende ragione di un fatto incontrovertibile e che ci aiuta a concettualizzarlo. Quando ognuno di noi parla, coltiva l’illusione che le parole corrispondano alle cose. Se dico a qualcuno “passami il sale” non è che ci sia da spremersi troppo le meningi circa l’azione che gli chiedo di compiere. La locuzione “passami il sale” e il significato di questa locuzione, ovvero l’azione richiesta dal locutore, coincidono; l’anello del simbolico in cui si fa la lingua e l’anello dell’immaginario in cui si rappresenta l’immagine della locuzione che si è prodotta si incrociano in un solo punto che ha tutta l’aria di non essere equivoco. Come ho detto, la parola è la cosa. D’altro canto quelli che tra noi non sono psicotici sanno però che la parola è supposta significare la cosa ma non è la cosa, tant’è vero che può esserci ambiguità, e si tratta qualche volta di un’ambiguità radicale, di locuzioni propriamente sibilline. Ad esempio questa: Ibis redibis non morieris in bello. È il responso della Sibilla ad un povero soldato che andava a chiederle se avrebbe riportato a casa la pelle dalla guerra per la quale stava partendo. Il responso scritto su quattro tavolette: “Ibis”, “redibis”, “non” e “morieris in bello”. Letteralmente significa: andrai, tornerai, non morirai in guerra”, oppure, a seconda che la pausa sia fatta prima o dopo il non, “andrai, non tornerai, morirai in guerra”. In effetti c’è una certa differenza. Quel che più importa è però che quest’ambiguità non è limitata all’oracolo uscente dall’antro della Sibilla. Al contrario è un’ambiguità connaturata al linguaggio. Non ci vuole molto per rendersi conto che dicendo a qualcuno “Fai come vuoi” si può voler riconoscere la libertà dell’interlocutore come si può volerlo abbandonare al suo destino. La cosa straordinaria è che l’intenzione del locutore è del tutto separata da quella supposta al locutore dal ricevitore del messaggio il quale potrà sentirsi libero o abbandonato indipendentemente dall’intenzione del primo. Se disponiamo della nozione di simbolico come separato dall’immagine che quel tratto linguistico evoca, e disponiamo ugualmente della nozione di reale come qualcosa che recede sullo sfondo vincolando il simbolico all’immaginario in un modo che non è completamente univoco essendo limitato alla funzione della lettera, allora noi siamo liberi di porci la questione del significato delle locuzioni che ci capita di sentire. Ovvero, l’incrocio in due punti di S e I, reso obbligatoriamente tale dall’interposizione tra S e I della consistenza di R, visualizza e ci rende percepibile l’ambiguità costitutiva del linguaggio. Al contrario, l’incrocio unico indica un solo significato univocamente legato al significante che lo esprime. Non esiste parola che non porti in se la propria scrittura, il reale della lettera: la semplice e innocua locuzione “da Milano” tesa ad indicare il luogo di provenienza del locutore può suonare per un orecchio psicotico, e di fatto è quello che è potuto succedere, come un’oscena ingiunzione a sfondo sessuale: “Dammi l’ano”. Questo significa che, in una certa misura, la scrittura, il ricorso al reale della lettera può risolvere l’ambiguità del significante ma che al fondo di questa ri-soluzione c’è poi una soluzione, ovvero uno scioglimento, una dis-soluzione del significante e dunque della significazione che non apre alla solidità della rappresentazione, bensì alla sua impossibilità, al reale della lettera. C’è una splendida narrazione autobiografica di Günter Grass che si intitola Sbucciando la cipolla[12]; sospetto fortemente che il titolo abbia a che fare col dato di struttura che ho appena indicato. Quando si sbuccia una cipolla, buccia dopo buccia, non si arriva alla “cipollosità” della cipolla, al suo ipotetico nucleo centrale. L’essenza della cipolla è di essere fatta di bucce sovrapposte che si sovrappongono sempre a solo ad un’altra buccia; sbuccia e risbuccia si piange, ma non si arriva da nessun’altra parte se non al reale di cui la cipolla è fatta, perdendo con questo ogni rapporto alla cipolla stessa.
Dunque la questione con la quale abbiamo a che fare nella cura di una psicosi è come permettere e facilitare il falso trifoglio in modo che non si verifichi uno scivolamento dell’immaginario fuori dallo spazio che circoscrive R e S (fig. E), che non si verifichi uno scivolamento di R fuori da S e I (fig. F) né, infine, che si possa verificare uno scivolamento di S fuori da R e I (figg. C e D) quello che sarebbe piuttosto qualcosa di simile ad un rafforzamento della forclusione.
Senza cadere in una delirante collazione tra forme del nodo e formazioni cliniche supposte corrispondervi, possiamo però utilizzare la topologia dei nodi per approfondire alcune delle evidenze che la clinica ci consegna. Di Barbara abbiamo già detto che immaginarizza un padre la cui immagine, non essendo simbolizzata, non lascia nessuno spazio al dubbio, all’ipotesi e alla sospensione del giudizio. Barbara sa sempre cosa il padre vuole da lei. Quando egli si trincera dietro lunghi silenzi e ostinati rifiuti di parlarle, Barbara impazzisce, e lo fa impazzire, per estorcergli quanto ella sa essere nella sua mente. L’immagine copre totalmente e coincide punto per punto col reale che, in quanto tale, ovvero come impossibile, cessa di esistere. Barbara sa, o almeno, sa che c’è da sapere.
Naturalmente quando Barbara mi rivolge il suo discorso o è per estorcermi il mio sapere che la riguarda oppure per chiedermi un aiuto nel lavoro di estorsione, ed eventualmente di correzione, del sapere del padre. In entrambi i casi è all’opera la stessa formazione transferale. Nel primo caso io sono il rappresentante, ma direi piuttosto il segno incontrovertibile e univoco, del funzionamento della psichiatria che, in quanto tale, è totalmente asservita alla strategia paterna. Non c’è voluto molto a correggere questa modalità di indirizzo. Il mio “no” riguarda il fatto che, prima ancora di non volere quel che Barbara mi suppone, io non voglio. Non la cerco, non ho obbiettivi, non ho finalità; semplicemente sono disponibile all’ascolto. Sono disponibile in una situazione che talvolta è estremamente difficile: piomba in Ospedale come una furia, annunciando con urla e strepiti il suo arrivo, irrompe nella stanza con voce arrochita dall’odio e grida improperi e accuse. Pochissimo spazio per articolare una parola o anche solo un ascolto che non sia totalmente succube e impotente di fronte al fiume d’odio che cola dalla sua bocca e dal suo sguardo. Il poco spazio che c’è cerco di utilizzarlo tutto: le dico qualcosa come: “non ora” oppure “le dispiace tornare tra un ora?”…”In questo momento sono impegnato, può passare più tardi?”. Sul momento questi limiti posti alla sua presenza non sembravano avere alcun effetto, ma adesso Barbara è più in grado di rimandare l’incontro/scontro col suo oggetto, di porre un freno o accettare che sia messo un freno al suo godimento. A partire da qui le accuse e gli improperi cadono, si sciolgono come neve al sole. Non ho neanche mai pensato di contrastarli, semplicemente li lascio passare, talvolta con un gesto della mano e un’espressione del volto che tende a indicare il fatto che si tratta di stupidaggini. Barbara lo coglie perfettamente, sempre, e in qualche modo si lascia rassicurare. Il suo oggetto, quel che io sono nel suo delirante investimento transferale, lascia il posto ad un po’ di reale simbolizzabile, parlabile, nominabile: “non ora”. Basta pochissimo e questo minimo di reale viene sussunto nell’immaginario che lo ricopre: io divento l’alter ego del padre, il competitor, colui che può affrontare il drago essendo lui stesso drago. In questa posizione mi chiede ovviamente di incontrare il padre, di lottare e di sconfiggerlo.
Come ho già ricordato, spesso Barbara mi ha parlato di un precedente terapeuta, morto, che lui sì che aveva capito, che lui sì sarebbe stato in grado, che lui sì avrebbe potuto antagonizzare il padre. Si tratta di una posizione investita simbolicamente, di un nodo tra simbolico e immaginario che non sopporta nessuna limitazione da parte del reale. Non c’è spazio per un minimo di castrazione e sono invece la privazione o la frustrazione che guidano la dinamica transferale di Barbara di fronte al suo oggetto. Per evitare di incorrere in quest’impasse, e per inserire, come si può, un minimo di accesso alla castrazione, metto avanti la mia impotenza: “non posso”. Non è che non voglia, che non mi senta autorizzato a farlo o che ne sia impedito da una qualche forma di timore verso l’autorità paterna, semplicemente non posso, come non posso volare o cambiare la sua sofferenza, fargliela cadere di dosso come lei mi chiede di far cadere il sapere paterno che la riguarda e del quale è oggetto.
Anche qui, in questo “non posso”, come già succedeva nel “non ora”, si tratta di un “no” che lascia trasparire dal simbolico che lo costituisce il reale che lo sottende. È questo il tratto che ne fa, o almeno ne rende possibile, la terapeuticità.
[1] Quella sul doppio è una letteratura che, oltre che affascinante, è anche molto ampia. Si va dal saggio di Rank (Il doppio, tr.it. SE 2001) al racconto di Gogol (Il naso, tr.it Einaudi 2004) alla fiaba di Andersen (L’ombra e altri racconti, tr.it. Orecchio Acerbo, 2005) al racconto di Stevenson (Il Dr Jakill e Mr Hyde, tr. it. Feltrinelli 1991), a quello di Poe (William Wilson, tr. it. Mondadori 2002) a quello di Saramago (L’uomo duplicato, tr. it. Einaudi, 2003), a quello di Dostoevskij (Il sosia, tr. it. Feltrinelli 2003) ai racconti di Hoffmann (Romanzi e racconti, tr. it. Einaudi 1969) e agli stessi racconti musicati da Hoffenbach, fino alla bella raccolta di Bovino Davico (L’io e l’altro. Racconti fantastici sul doppio, Einaudi 2004).
[2] “Ciò che è impossibilitato a venire all’interno viene all’esterno” (Freud) e “ciò che è forcluso nel simbolico torna nel reale”.(Lacan). Queste due proposizioni, citate a memoria, indicano lo stesso concetto, ovvero che l’oggetto che si presenta all’esterno, nel reale, sotto la forma di allucinazione o di idea delirante, è il corrispettivo di un oggetto impedito da una resistenza specificamente psicotica (Verwerfung o, come tradotto da Lacan, forsclusione) a presentarsi all’interno dell’apparato psichico in quanto rappresentazione.
[3] È un caso ma, nello stesso tempo, non è un caso se le due locuzioni “Io e Dio” e “Io ed Io” hanno la stessa identità fonetica. Non è poi così facile distinguere tra le due. Per inciso ricordo che Io e Dio è anche il titolo di un bel libro di Vito Mancuso (Garzanti, 2011) che, da questo punto di vista, può essere letto in continuità con Eclisse del Dio unico (F. Palazzoli, Il Saggiatore, 2012) che evoca la dimensione di una religiosità prét à porter nella quale a ognuno è concesso di credere al suo Dio, come si diceva: Io ed Io, piuttosto che Io e Dio. A riprova del fatto che si tratta di qualcosa che caratterizza lo spirito dei tempi, lo stesso concetto, ovvero quello di una sorta di politeismo di ritorno, si trova espresso anche da Ulrich Beck (Il Dio personale, tr. it. Laterza, 2009).
[4] Da quello che ricordo del racconto in verità una specie di simmetria viene ripristinata, sia pure a senso inverso, ed è questo che consente al postino di sfuggire all’animale. Ad un certo punto infatti il postino si rende conto che l’animale percepisce la paura che provoca ed è la paura di diventarne preda che fa di un altro animale una sua preda. Quindi basta non aver paura di ciò che si presenta come fonte di paura e il gioco è fatto: la preda cessa di essere tale.
[5] Cfr. Fabrizio Gambini, La Nuova Storia di Pinocchio. Ovvero la Nuova Economia Psichica (NEP) al tempo del seno come segno della differenza tra i sessi, in “Psichiatria/Informazione”, III – 2013, p. 43.
[6] È un altro modo di intendere la nozione di “doppio legame”: un legame che si fa doppio legando il soggetto impedito a divenire all’oggetto che quel soggetto è per l’Altro.
[7] A titolo di aneddoto integrativo ricordo che l’omone dormiva in un lettino nel tinello, coperto di ciniglia rosa e sul quale troneggiava un’enorme bambola.
[8] Cfr. Fabrizio Gambini, La Nuova Storia di Pinocchio, cit. Inoltre tutta la questione della “simmetria” e della sua mancanza nell’esercizio della sessualità si rapporta molto precisamente a quanto Lacan tratta nel Seminario dedicato al Sinthome e a questo si rimanda: Là où il y a rapport, c’est dans la mesure où il y a Sinthome, c’est-à-dire où, comme je l’ai dit, c’est du Sinthome qu’est supporté l’autre sexe…Le Sinthome se caractérise de la non-équivalence. J. Lacan, Le Sinthome, Lezione del 17 febbraio 1976, p. 138-139.
[9] Immaginare il nodo tra immaginario, reale e simbolico (I,R e S) è già un modo per entrare nel vortice abissale a cui il nodo apre: l’immaginario attraverso cui si immagina la funzione dell’immagine, è un immaginario diverso da quello che è immaginato come oggetto della nostra riflessione? Nella proposta che Lacan fa del nodo a più riprese e in diverse forme la questione è sempre presente e trattata a partire dal fatto che immaginaria è la consistenza della corda con la quale si fa un nodo tra immaginario, reale e simbolico, anche se una delle conseguenze di una forma particolare dell’annodamento (nodo borromeo) è che i tre anelli (I, R e S) devono risultare strettamente equivalenti, ovvero che ognuno deve essere il terzo necessario rispetto agli altri due affinché vi sia tenuta del nodo stesso.
[10] Cfr. F. Gambini, Paranoie, in corso di stampa.
[11] La questione è stata già accennata in un scritto al quale rimando per un suo approfondimento nel contesto del quale quello scritto trattava: F. Gambini, Un ricovero come esperienza di libertà, parte I e II, in “Psichiatria/Informazione” numeri
[12] G. Grass, Sbucciando la cipolla, tr. it. Einaudi 2007.
Fabrizio Gambini – Perseguitare il persecutore, ovvero cosa ne è della Paranoia nella società dell’immagine?
Saggio per un’analisi topologica di una forma di psicosi nella Nuova Economia Psichica.
Nell’interlocuzione tra l’Io e un’allucinazione non è mai questione di simmetria. Non c’è alcuna forma di simmetria tra l’Io stesso e l’oggetto che si presenta come allucinazione. È un altro modo per dire quel che Freud già notava, ovvero che l’oggetto, quando si presenta, è presente su uno sfondo d’angoscia. L’angoscia accompagna sempre una percezione il cui tratto fondante è la mancanza di simmetria rispetto all’Io per cui si produce.
È questo l’incubo della materializzazione del doppio: l’immagine speculare che ci corrisponde, col braccio sinistro che gratta lo stesso naso che noi grattiamo col destro, cessa di essere speculare, si anima di un’anima che non è la nostra, e smette di corrisponderci. A ben vedere non è neanche sicuro che si tratti dello stesso naso perché, ad esempio, nel caso che sul naso si abbia un neo sulla narice destra, l’immagine corrispondente mostra un naso fornito di neo a sinistra. La simmetria è in fondo la garanzia di un ordine che fa sì che il mondo che vediamo corrisponda ordinatamente a ciò che supponiamo ci sia lì dove qualcosa vediamo. Si tratta della simmetria fondamentale che costituisce la garanzia della relazione biunivoca e simmetrica tra ciò che è impresso sulla retina come immagine e quanto c’è nel mondo la cui immagine ci rappresentiamo. Ma quando l’immagine in sé si anima? Quando si rende cioè indipendente e si mette lei, l’immagine, ad esistere? Allora la simmetria costitutiva del nostro mondo si rompe e la mancanza di simmetria che caratterizza l’insorgenza del doppio genera angoscia. Da questa angoscia, a protezione dall’angoscia stessa, si genera l’idea del persecutore. È quello che succede al personaggio di Gogol che si trova perseguitato dal proprio naso, è quello che succede al personaggio della fiaba di Andersen che si trova perseguitato e condannato a morte dalla propria ombra, è quello che avviene al Dr Jekyll perseguitato dall’odioso Hyde, ed è quello che avviene a Tertuliano Máximo Afonso per aver noleggiato una videocassetta. In sostanza è quello che sempre avviene nel momento in cui la fantasia dei romanzieri evoca l’incontro impossibile col doppio.[1]
Il doppio infatti è quanto ci corrisponde, senza però corrispondere per questo all’immagine che noi ci facciamo del mondo. A prima vista non tutti gli oggetti che ci corrispondono e animano un Reale diverso dalla nostra realtà, sembrerebbero avere la caratteristica di essere “doppio”, ma, a ben vedere, c’è qualcosa che spinge comunque in questa direzione. Che dire, ad esempio, del Dio che parla all’Io dal luogo della forclusione dell’istanza paterna? Il Dio della psicosi, in qualche modo, è sì un doppio dell’istanza paterna,[2] ma un doppio che non possiamo riconoscere come tale, non avendo accesso all’originale così duplicato. Il risultato è che la percezione allucinatoria compare, come si è detto, su sfondo d’angoscia. Evidentemente il rapporto tra Io e Dio è altra cosa del rapporto tra Io ed Io[3]: il Dio che parla allo psicotico è un altro Dio da quello che l’Io si rappresenta come oggetto della fede che sceglie di testimoniare. Siamo un po’ nella situazione evocata da quella barzelletta, puntualmente e acutamente segnalatami dalla persona alla quale avevo accennato, per discuterne, il contenuto di questo scritto, e nella quale un signore si trova totalmente solo in cima ad una montagna e di fronte ad un panorama grandioso. Si guarda intorno, guarda in alto, e comincia a gridare: “C’è qualcuno?” Sempre più angosciato e inquieto, grida sempre più forte, fin quando una voce dal cielo risponde “Dimmi figlio mio”. “Chi sei?” interroga l’uomo, e la voce risponde “Io sono Dio”. “E come faccio a saperlo?” interroga di nuovo l’uomo. “Gettati nel vuoto affinché i miei angeli ti possano raccogliere e portarti da me” risponde serena la voce. L’uomo, incerto, si guarda un po’ intorno e grida: “C’è qualcun altro?”
Il punto fondamentale dunque è che quello che ci corrisponde nel registro della psicosi, ad esempio le allucinazioni che noi produciamo, non ci corrisponde nel registro immaginario, e per questo simmetrico, in cui l’Io riconosce il mondo e riconosce se stesso. Per questo, ripeto, l’insorgenza dell’oggetto nel nostro campo percettivo avviene e non può che avvenire su sfondo d’angoscia.
Non è l’unica caratteristica dell’oggetto. Ad esempio ce n’è una seconda che è quella della reciprocità. Ma la reciprocità non è la simmetria. Da un oggetto orale si può essere mangiati, da ciò che vediamo possiamo essere visti ma, ripeto, questa reciprocità non è simmetria e, non essendo simmetria, non è in grado di proteggerci dall’angoscia. Che dire, ad esempio, di una madre che dica al proprio bambino: “Ti mangerei di baci”? La fonte di nutrimento si fa divoratrice. Dove collocare un amore del quale si è oggetto e in nome del quale si può essere nutriti, vezzeggiati e, nello stesso tempo, divorati?
Non saprei citare l’autore o il titolo, ma ricordo perfettamente un breve racconto di fantascienza in cui una specie di postino spaziale naufraga con la propria astronave su un pianeta sconosciuto e lì si imbatte in un enorme animale simile ad una pantera. Della pantera l’animale ha il corpo, i peli, la bocca, le zanne e gli artigli, ma non ha gli occhi né il naso né le orecchie. La testa assomiglia piuttosto ad una grossa palla di pelo il cui aspetto è tale da far pensare che l’animale voglia aggredire e divorare l’uomo. Nel suo cercare di sfuggire all’animale, l’uomo si chiede con quali sensi l’animale lo individui, per capire come nascondersi: sottrarsi allo sguardo su o dietro un albero, sottrarsi all’olfatto rotolandosi nella terra o immergendosi nell’acqua, sottrarsi all’udito restando in assoluto silenzio? Come sfuggire a chi ti segue senza occhi per vedere, orecchie per sentire e naso per annusare?[4] In forma romanzata è la questione che Lacan pone nel seminario sull’angoscia quando evoca l’immagine di una mantide religiosa nel cui occhio prismatico non ci si può specchiare. Non sappiamo cosa e chi siamo per lei che, insieme, ci ama e ci divora. È da questa forma d’angoscia che la simmetria dell’immagine ci protegge: occhio per occhio, dente per dente, punto per punto. L’allucinazione, il ritorno dell’oggetto nel reale, pur essendo preso nella reciprocità, manca di questa simmetria, e per questo genera angoscia.
Un modo per proteggerci dall’angoscia generata da questa specifica mancanza di simmetria, senza per questo sprofondare in un rapporto puramente immaginario tra l’Io ed il suo Tu speculare che, in quanto tale, non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io, è il riconoscimento della funzione della differenza sessuale. Molto banalmente, questo significa potersi inscrivere, ad opera della castrazione, in una soggettività sessuata.
Vale la pena, a questo punto, di fare una piccola digressione, circa le modalità con le quali il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge dal presentarsi dell’oggetto in quanto fonte d’angoscia. Di questo si hanno tracce imponenti quanto evidenti: ho visto recentemente un adolescente precipitato in una crisi di panico dal pensiero che forse era all’inizio di una relazione d’amore, e di sesso, con una compagna di scuola. Se la relazione non è col simile, con lo speculare, col simmetrico e, per questo, col prevedibile, la relazione stessa diventa fonte d’angoscia: per salvarsi, ha dovuto fuggire, come il postino spaziale o come davanti ad una mantide religiosa.
Usualmente il nostro strutturale sentimentalismo ci porta a pensare che là dove c’è sesso, possa eventualmente esserci anche amore. Talvolta ci spingiamo addirittura a pensare il sesso come conseguenza sciagurata della caduta dell’amore e al ritorno all’amore come guarigione dal sesso. Per introdurre invece il punto centrale di quel che intendo con la nozione di ineliminabilità della presenza della divisione sessuale per quanto riguarda la protezione dall’angoscia, vorrei provare a rovesciare la frase nel modo seguente: là dove c’è amore siamo sicuri che, se le vanno come devono andare, c’è sesso, ovvero è il sesso che consentirebbe una sorta di guarigione dall’amore, che ne consentirebbe, diciamo così, un esercizio temperato. Si tratta di una proposizione che, a ben vedere, è decisamente fastidiosa e, direi, poco digeribile ai più.
Finché la questione riguarda un uomo e una donna siamo tranquilli, ben installati nel nostro senso comune come in una pantofola, ma la stessa proposizione può ugualmente riguardare due uomini o due donne, così come riguarda madri, padri, figli e figlie, e come riguarda la relazione che ognuno di noi ha con il prossimo, del quale ci dicono che andrebbe amato come amiamo noi stessi. La frase riguarda dunque anche la relazione che abbiamo con noi stessi e, infine, riguarda l’amore degli amori, il modello di ogni amore, ovvero l’amore che l’essere umano ha per Dio e il suo reciproco: l’amore che l’uomo suppone a Dio nei suoi confronti.
Quando dico che quello per Dio è il modello di ogni amore, intendo qualcosa di molto preciso, ovvero che è modello di ogni amore perché è amore nella sua forma pura, nella sua forma perfettamente soggettiva, in quanto rivolto a ciò che non c’è: amore per ciò che non esiste. Il punto è che questa forma di assenza dell’oggetto è caratteristica di ogni forma d’amore e, ripeto, è per questo che l’amore per Dio è il modello di ogni forma d’amore. L’oggetto d’amore non c’è, come non c’è Beatrice per Dante, Laura per Petrarca e Silvia per Leopardi. Tutt’e tre, Beatrice, Laura e Silvia, hanno dovuto non esserci per poter esistere per sempre per ognuno di noi in quanto trasfigurate dall’amore di uno di noi.
L’amore è amore dell’assenza, è amore della mancanza. L’amore è nostalgia, è lontananza. Lo celebra una vecchia canzone di Domenico Modugno: “La lontananza sai è come il vento…” che non ricordo esattamente cosa faccia ma che, in sostanza, trasforma in incendi i fuocherelli, e lo celebra una celebre immagine di Levinas, che metaforizza l’incontro con l’altro come una carezza, ovvero un gesto pudico di ritiro e di allontanamento.
Ora, il sesso è precisamente ciò che istituisce la mancanza che, quando funziona come si deve, genera carezze, ovvero amore.
Questo vuol dire, ad esempio, che c’è divisione sessuale tra una madre e suo figlio e, se c’è divisione sessuale, è fondamentale che ci sia riconoscimento della stessa e che, conseguentemente, possa esserci la sua simbolizzazione, ovvero il suo farsi parola. Forse è necessario ricordare a questo punto la psicoanalisi e l’accusa di pansessualismo che a questa è stata e continua ad essere rivolta. Su questo, sull’importanza della teoria sessuale per Freud, ci sarebbe da interrogarsi al lungo[5], per il momento limitiamoci ad osservare che una madre che abbia parole per nominare la distanza, che l’accetti come costitutiva della relazione, potrà volere il bene di suo figlio senza per questo volere la perfetta corrispondenza tra il figlio e l’oggetto immaginato come necessario al compimento del suo ben-essere di madre. Pensate all’amore di Maria per Gesù, amato come figlio e “lasciato” libero di morire in croce per compiere qualcosa che riteneva parte necessaria del suo percorso. Ma, molto più in piccolo, penso alla madre di un mio paziente, un omone di 120 kili del quale la madre è riuscita a dire: “Lei lo sa dottore, per me N. è come un figlio”. Chi assisteva con me al colloquio l’ha preso come una sorta di lapsus con il quale si prendeva una certa distanza dalla maternità e dalla responsabilità della stessa. È strano, ma io l’ho presa al contrario: avere un figlio può succedere; succede alle leonesse e alle tigri come alle donne, ma che N. fosse come un figlio, implica una scelta, un rafforzamento, un raddoppiamento[6] e una conferma solo umana del legame biologico. Ovvero ho letto in quel “come”, la cifra di un disconoscimento, di un mancato riconoscimento della differenza sessuale che separasse l’omone da ciò che era per sua mamma.[7]
Al contrario, il riconoscimento della differenza sessuale, questa introduzione nella dialettica io – tu di una differenza che, ripeto, è sessuale, impedisce lo svolgersi di un rapporto sterile, a prodotto zero, puramente immaginario tra l’Io e il suo Tu speculare, che non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io.
È da questo che il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge. Più in generale non si tratta solo di protezione dalla psicosi, ma anche del fatto che, ad opera del riconoscimento della differenza, siamo protetti dalla contingenza moderna che vede il trionfo dell’immaginario e l’annegamento del desiderio nella concupiscenza dell’oggetto di consumo.
In questo contesto l’altra metà dell’androgino, la metà perduta, non sarebbe, diciamo così, l’altra metà della mela, bensì l’immagine speculare dell’unica metà che, in quanto immagine, sostiene l’illusione dell’esistenza della mela in quanto intero. Ne consegue che la sessualità è ciò che consente a tutte le mezze mele che siamo di sopportare di essere divise e, insieme, di avere a che fare con altre mezze mele, anche loro auspicabilmente sopportanti di essere mezze. [8]
Sappiamo bene che è per questa ragione che nella psicosi, caratterizzata da una peculiare difficoltà di accesso alla castrazione, resta la traccia di una difficoltà nel riconoscimento della differenza tra i sessi. Freud direbbe che resta la traccia della fondamentale bisessualità dell’essere umano, resta, in ogni caso, come una specie di ordito che soggiace alla tela in cui si rappresenta ogni forma unica, individuale e irripetibile di psicosi.
Anche nel caso del quale intendo parlare c’è una traccia di questo, e Barbara, puntualmente, narra di un passato “gravato” da difficili esperienze omosessuali. Adesso non ha una vita sessuale e il sesso sembra essere l’ultimo dei suoi problemi. La peculiarità di Barbara, la cifra della sua situazione psicopatologica, non sta però nella sua presunta omosessualità, bensì nel modo in cui Barbara nega la funzione della differenza nella relazione Io – Tu, interloquendo con un altro immaginario che non sarebbe nient’altro che lo specchio dell’Io, se non fosse che il gioco tra l’oggetto a e l’oggetto a1 fa comparire nello specchio l’oggetto, dando all’altro della relazione immaginaria la funzione di persecutore. In altre parole, il sintomo, piuttosto che operare come una sorta di raddoppiamento del simbolico, nel caso di Barbara, opera piuttosto come un raddoppiamento dell’immaginario, in un gioco tra a e a1 che esclude ogni rassicurante simmetria nello specchio dell’Io.
Partiamo, per provare a rappresentare questa situazione, dal gioco tra immaginario, reale e simbolico.
È un gioco che possiamo immaginare[9] attraverso un falso nodo a trifoglio:
Qui, nel falso nodo a trifoglio, avremo che la separazione, e dunque la possibilità di funzionamento simultaneo R. S e I in quanto separati, è data soltanto dal ripiegamento del tratto orizzontale della corda verso l’alto e che niente impedisce al trifoglio di diventare un otto, e all’otto di diventare un cerchio, ovvero uno spazio in cui non è possibile alcuna articolazione tra R,S e I: quello che sarebbe una sorte di morte psichica, una resa totale alla schizofasia, al gioco totalmente anarchico e disarticolato tra lettera, significante e significato. Affinché questo falso nodo tenga, consentendo almeno una parvenza di psichismo, è dunque necessario ricorrere ad una seconda corda, che può essere posizionata in diversi punti:
Il primo (fig. 1) fissa l’incrocio in basso in modo da lasciare possibile in ogni momento la costruzione di un otto in cui S è separato dallo spazio comune di R e I.
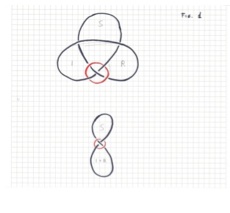 Il secondo (fig 2) fissa l’incrocio a sinistra in modo da consentire un otto in cui R è separato dallo spazio comune costituito dalla coincidenza di S e I:
Il secondo (fig 2) fissa l’incrocio a sinistra in modo da consentire un otto in cui R è separato dallo spazio comune costituito dalla coincidenza di S e I:
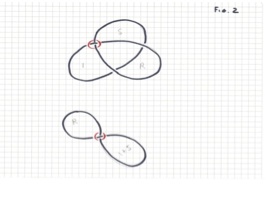 Il terzo infine fissa l’incrocio a destra in modo da rendere impossibile il disfacimento della forma a trifoglio (fig. 3) e dunque l’articolazione e separazione tra S, R e I.
Il terzo infine fissa l’incrocio a destra in modo da rendere impossibile il disfacimento della forma a trifoglio (fig. 3) e dunque l’articolazione e separazione tra S, R e I.
Direi che per Barbara qualcosa è successo che ha legato i tre registri nel modo indicato dalla figura 1, ovvero una sorta di forclusione del simbolico che lascia totalmente separato lo spazio comune al reale e all’immaginario. Il reale è quel che Barbara immagina che sia e, nella realtà, questo reale compare come un’ombra pervasiva, come un doppio strisciante che la getta nell’angoscia. Mancanza di simmetria, l’abbiamo detto, ma non mancanza di reciprocità e dunque l’odio per l’ombra crea l’odio da parte dell’interlocutore che da quest’ombra è investito. In altre parole, gli accidenti della sua vita, l’hanno portata ad annodare i registri all’incrocio di I e R (fig. 1). Questo significa che l’oggetto a si raddoppia immaginariamente in un oggetto a1 del quale non c’è modo di liberarsi e che non cessa di segnare, con la sua angosciante presenza, l’altro dell’interlocuzione immaginaria. Fermo restando quell’annodamento, si è prodotta una irrimediabile separazione tra S da un lato, e I ed R dall’altro. E anche questo è un modo per rappresentare qualcosa della forclusione del simbolico che costituisce il tratto propriamente paranoico di Barbara.
Il padre, professionalmente affermato, ha su di lei e sul suo corpo un potere di vita e di morte. Barbara ricorda, o meglio, pensa e teme di ricordare, un episodio un po’ confuso: lei bambina su un divano, qualcuno, forse un amico del padre, era seduto sullo stesso divano e delle carezze o un contatto le hanno fatto pensare che il padre, presente nella stanza, la offrisse quale oggetto di godimento sessuale alla concupiscenza dell’altro. Se dichiarava la sua difficoltà, se cercava aiuto, in questa come in molte altre circostanze successive, la domanda d’aiuto era bollata come malattia dal padre che, a causa del suo potere sociale e professionale, e intendo con questo il potere pressoché infinito che Barbara suppone al suo terrificante padre immaginario, trovava sempre chi ratificava questa sua diagnosi, impedendo così all’urlo di dolore di Barbara di essere altra cosa che una espressione sintomatica, scaturita come un fungo dal suo micelio dal luogo oscuro della follia di Barbara. Qui non si tratta di metafore. Al centro della questione si trova infatti la voce o, se preferite, l’orecchio che questa voce raccoglie. È l’orecchio/voce che, letteralmente, incarna per Barbara il persecutore. I vicini la odiano e la perseguitano perché odono le sue urla, e non si rendono conto che lamentandosi di queste, la spingono ad urlare sempre di più, in una spirale senza fine. Adora il telefono, è il suo strumento preferito. Quando mi parla, anche di persona, nei momenti in cui mima la voce dell’Altro (il padre, un vicino), la sua voce si arrochisce, si trasforma e si carica d’odio come una nuvola dell’acqua di un temporale. Lo stesso tono a tratti compare, non come mimesi dell’altro che la perseguita, bensì come effetto del suo rivolgersi a me, quando mi ingiuria. In questa circostanza è lei il persecutore che mi accusa di perseguitarla in quanto rappresentante di una psichiatria che non ha con lei altro rapporto se non quello determinato dal suo essere lo strumento coercitivo e violento della volontà persecutoria del padre. L’annodamento di Barbara si è fatto tra un padre immaginario e terrificante che minaccia, punisce ma che non istituisce una regola riconoscendo la quale si avrebbe diritto all’amore. La domanda d’amore, rivolta a quell’oggetto immaginario, diventa persecuzione, diventa stimolo alla punizione, all’esercizio della violenza. Quello di Barbara è un odio/amore che genera odio. Barbara diventa così una specie di stalker,[10] preda di una paranoia che ha la preoccupazione di costruire concretamente, nella realtà, il proprio persecutore, e lo fa nell’unico modo che conosce, perseguitandolo. D’altronde è l’odio che si situa alla giunzione tra immaginario e reale ed è lì che Barbara si è trovata a fare il suo annodamento. Il simbolico resta fuori campo, escluso dal tentativo di far coincidere la realtà col reale annodato all’immaginario.
Questa situazione domanda una particolare cura per essere maneggiata ed è una cura alla quale si deve sempre molta attenzione quando si tratta di maneggiamento di un transfert psicotico. Bisogna fare attenzione a che, nella gestione transferale di una situazione del genere di quella descritta, non si vada formando un annodamento di tipo 2 che vede l’immaginarizzazione di un padre simbolico a scapito di una specie di “forclusione” del Reale che non ne consente alcuna caduta. Barbara mi parla di un precedente terapeuta, morto, che lui sì che aveva capito, che lui sì sarebbe stato in grado, che lui sì avrebbe potuto antagonizzare il padre. Ciò a cui bisogna fare attenzione è di non trovarsi mai nella posizione del terapeuta morto, ovvero di chi lui sì. È una posizione che apre fatalmente a reazioni terapeutiche negative. Il reale non metabolizzabile di questa immaginarizzazione di un transfert simbolico, ritorna sempre e ritorna con la carica di odio che puntualmente si presenta alla giunzione tra reale e immaginario.
Eppure si tratta di provare ad operare uno spostamento del nodo dalla posizione in cui il legame tra immaginario e reale forclude il simbolico (fig. 1), ma si tratta di spostarlo verso il legame tra simbolico e reale che, come si vede dall’immagine del nodo, non “forclude” nessuno dei tre registri, bensì li tiene annodati in modo che questi possano funzionare all’unisono ma separati tra loro.
Ora, per forzare il transfert a costruire questo tipo di quarto anello (fig. 3) non è che ci siano molti modi, anzi, sempre più, con l’avanzare della mia esperienza nel trattamento di quadri psicotici gravi, mi pare che il modo sia uno solo ed è quello di far valere, in un certo modo, la funzione del “no”.[11]
Il “no” di cui si tratta è un “no” al quale un agente sia supponibile. Questo significa che quel “no” non sarà un puro Reale che, a rigor di termini, renderebbe letteralmente non esistente l’oggetto negato, e che non sarà neanche il riflesso di una posizione immaginaria (fin troppo facilmente percepibile come contrap-posizione) attribuita all’altro che detta la sua legge violenta e arbitraria. Piuttosto il “no” che andiamo ricercando è la funzione di un limite percepito come il riflesso di un po’ di Simbolico, del poco Simbolico che il soggetto può avvicinare, avvicinandosi così, nella misura del possibile per lui, a qualcosa che sarebbe vagamente dell’ordine della castrazione.
[1] Quella sul doppio è una letteratura che, oltre che affascinante, è anche molto ampia. Si va dal saggio di Rank (Il doppio, tr.it. SE 2001) al racconto di Gogol (Il naso, tr.it Einaudi 2004) alla fiaba di Andersen (L’ombra e altri racconti, tr.it Orecchio Acerbo, 2005) al racconto di Stevenson (Il Dr Jakill e Mr Hyde, tr. it. Feltrinelli 1991), a quello di Poe (William Wilson, tr. it. Mondadori 2002) e a quello di Saramago (L’uomo duplicato, Einaudi, 2003), fino alla bella raccolta di Bovino Davico (L’io e l’altro. Racconti fantastici sul doppio, Einaudi 2004).
[2] “Ciò che è impossibilitato a venire all’interno viene all’esterno” (Freud) e “ciò che è forcluso nel simbolico torna nel reale”.(Lacan). Queste due proposizioni, citate a memoria, indicano lo stesso concetto, ovvero che l’oggetto che si presenta all’esterno, nel reale, sotto la forma di allucinazione o di idea delirante, è il corrispettivo di un oggetto impedito da una resistenza specificamente psicotica (Verwerfung o, come tradotto da Lacan, forsclusione) a presentarsi all’interno dell’apparato psichico in quanto rappresentazione.
[3] È un caso ma, nello stesso tempo, non è un caso se le due locuzioni “Io e Dio” e “Io ed Io” hanno la stessa identità fonetica. Non è poi così facile distinguere tra le due. Per inciso ricordo che Io e Dio è anche il titolo di un bel libro di Vito Mancuso (Garzanti, 2011) che, da questo punto di vista, può essere letto in continuità con Eclisse del Dio unico (F. Palazzoli, Il Saggiatore, 2012) che evoca la dimensione di una religiosità prét à porter nella quale a ognuno è concesso di credere al suo Dio, come si diceva: Io ed Io, piuttosto che Io e Dio. A riprova del fatto che si tratta di qualcosa che caratterizza lo spirito dei tempi, lo stesso concetto, ovvero quello di una sorta di politeismo di ritorno, si trova espresso anche da Ulrich Beck (Il Dio personale, tr. it., Laterza, 2009).
[4] Da quello che ricordo del racconto in verità una specie di simmetria viene ripristinata, sia pure a senso inverso, ed è questo che consente al postino di sfuggire all’animale. Ad un certo punto infatti il postino si rende conto che l’animale percepisce la paura che provoca ed è la paura di diventarne preda che fa di un altro animale una sua preda. Quindi basta non aver paura di ciò che si presenta come fonte di paura e il gioco è fatto: la preda cessa di essere tale.
[5] Cfr. Fabrizio Gambini, La Nuova Storia di Pinocchio. Ovvero la Nuova Economia Psichica (NEP) al tempo del seno come segno della differenza tra i sessi, in “Psichiatria/Informazione”, III – 2013, p. 43.
[6] È un altro modo di intendere la nozione di “doppio legame”: un legame che si fa doppio legando il soggetto impedito a divenire all’oggetto che quel soggetto è per l’Altro.
[7] A titolo di aneddoto integrativo ricordo che l’omone dormiva in un lettino nel tinello, coperto di ciniglia rosa e sul quale troneggiava un’enorme bambola.
[8] Cfr. Fabrizio Gambini, La Nuova Storia di Pinocchio, cit. Inoltre tutta la questione della “simmetria” e della sua mancanza nell’esercizio della sessualità si rapporta molto precisamente a quanto Lacan tratta nel Seminario dedicato al Sinthome e a questo si rimanda: Là où il y a rapport, c’est dans la mesure où il y a Sinthome, c’est-à-dire où, comme je l’ai dit, c’est du Sinthome qu’est supporté l’autre sexe…Le Sinthome se caractérise de la non-équivalence. J. Lacan, Le Sinthome, Lezione del 17 febbraio 1976, p. 138-139.
[9] Immaginare il nodo tra immaginario, reale e simbolico (I,R e S) è già un modo per entrare nel vortice abissale a cui il nodo apre: l’immaginario attraverso cui si immagina la funzione dell’immagine, è un immaginario diverso da quello che è immaginato come oggetto della nostra riflessione? Nella proposta che Lacan fa del nodo a più riprese e in diverse forme la questione è sempre presente e trattata a partire dal fatto che immaginaria è la consistenza della corda con la quale si fa un nodo tra immaginario, reale e simbolico, anche se una delle conseguenze di una forma particolare dell’annodamento (nodo borromeo) è che i tre anelli (I, R e S) devono risultare strettamente equivalenti, ovvero che ognuno deve essere il terzo necessario rispetto agli altri due affinché vi sia tenuta del nodo stesso.
[10] Cfr. F. Gambini, Paranoie, in corso di stampa.
[11] La questione è stata già accennata in un scritto al quale rimando per un suo approfondimento nel contesto del quale quello scritto trattava: F. Gambini, Un ricovero come esperienza di libertà, parte I e II, in “Psichiatria/Informazione” numeri
Charles Melman – Un paio di mutande per due. L’ideale della parità nel mondo industriale.
Come sapete noi facciamo del sesso una questione di sentimenti. Il problema è che ciò che primordialmente determina il sesso è una struttura completamente indifferente ai sentimenti che possiamo provare e che ci piacerebbe comandassero la relazione.
E’ chiaro che se non siamo avvertiti delle particolarità strutturali che ordinano per noi il sesso, continueremo sicuramente a vivere la relazione nella dimensione del sogno, della rivendicazione, dell’utopia, del malessere e oggi anche, perché no? della rivendicazione sociale.
E’ evidente che su questo punto [….] si gioca un po’ la vita di ognuno, malgrado ciò che se ne pensi o, direi, se ne sappia. Sulla questione della relazione sessuale e dell’identificazione sessuale abbiamo, dopo la psicanalisi e in particolare dopo Lacan, delle formulazioni avanzate che, è interessante constatarlo, restano essenzialmente fuori dal movimento culturale. Intendo dire che tutto continua ad avvenire come se non fosse stato proposto niente con la volontà certa d’immaginare le relazioni tra uomini e donne, e quelle che ognuno ha col proprio sesso, meno conflittuali e che sfocino meno in ciò che viviamo da decenni, cioè nella “guerra dei sessi”.
A che punto siamo con l’identificazione sessuale? [….]Per ognuno di noi l’identificazione sessuale si gioca a livello di quattro fattori. Né più né meno. [….]
Il fattore della realtà del proprio sesso, del proprio sesso anatomico, quello con cui si è venuti al mondo… e che ci colloca da un lato o dall’altro, dal lato uomo o dal lato donna.
E’ un’identificazione principale perché non è solo reale ma assume anche per ognuno, e in generale per le famiglie, un senso simbolico perché sembra corrispondere alla volontà di colui che avrebbe deciso la cosa, del potere tutelare che decide della differenza dei sessi: l’anatomia assume perciò anche un carattere simbolico.
In altri termini: non è solo l’effetto del caso. Il 51%, il 49% ha determinato l’identità del sesso ma è anche la “volontà tutelare” che colloca ogni individuo fin dalla nascita in una delle due categorie.
(Il fattore) simbolico: ha dei sensi, come dire?
Può avere un senso molto preciso perché significa che l’identità, all’inizio “ bestialmente anatomica” , animale, se posso esprimermi così, si inscrive nella vocazione di chi nasce di trovarsi uomo o donna, vale a dire incaricato di un dovere. Di un dovere che, nel caso, si prende gioco anche di ciò che potrebbe essere il suo piacere e che definirei la sua determinazione singolare: se è Uomo oppure Donna viene al mondo con il compito che fa sì che egli sia riconosciuto dai suoi simili a condizione di mostrarsi rappresentante di questa potenza tutelare, uno dei suoi agenti, con il compito di assicurare la posterità del lignaggio.
Questo vale per entrambi i sessi ma in modo eminente per il sesso femminile perché, come sappiamo, la valutazione delle proprie qualità femminili è sottomessa alla capacità, o alla volontà, di essere madre.
In genere assistiamo alla scomparsa del riconoscimento che la donna potrebbe aspettarsi dei tratti della propria femminilità, una scomparsa rispetto ad una ricerca voluta socialmente e socialmente validata. Una ricerca di maternità che, più che i tratti specifici della sua femminilità, la farebbero in qualche modo entrare nel cerchio sociale [….]ecco un carattere simbolico la cui brutalità, direi, ci fa intravvedere in che modo esso sottomette la singolarità di ognuno ad un regola culturale, sociale.
A parte il fatto che il termine Uomo o Donna non è solo sinonimo di un dovere da compiere ma anche la cancellazione di quelli che potrebbero essere i desideri di questa o di quello a profitto del compito che gli ritorna. Non ho bisogno di insistere su questo punto, sappiamo in che modo lei, (la donna che diventa madre) sia festeggiata dalla famiglia e dal sociale.
Il terzo fattore dell’identificazione sessuale è il fattore immaginario.
E’ un fattore importante perché comanda nella specie umana tutto ciò che fa parte della parata sessuale; è un fattore decisivo.
C’è dunque un certo numero di tratti che si possono celebrare, denunciare, il maschilismo da un lato e la seduzione dall’altro, vale a dire modalità culturali di rappresentarsi nelle manifestazioni della propria identità sessuale.
E’ evidente che i numerosi miti che testimoniano della violenza con cui ha potuto effettuarsi il primo “ratto” di donne, rendono conto, senza alcun dubbio, della paura che le donne ispirano alla specie maschile; nella misura in cui la verifica dell’identità maschile, che all’inizio , in modo inaugurale, è assicurata di per sé, dipende poi dalla loro accettazione, dal loro accordo.
Sappiamo anche che il patto tra un uomo e una donna non può essere che simbolico- primordialmente non è un patto sottoscritto dal notaio- originariamente è un patto simbolico. Si tratta dell’accettazione da parte dell’uno o dell’altro della mancanza che è al centro della relazione di concubinaggio o coniugale e questa mancanza, questa incompletezza, questa defezione, che riguarda l’uno e l’altra si dovrà assumere oppure no rispetto a questo compito che, come sappiamo, può essere incessantemente ricusato.
E’ qui il motivo, la causa di tutte le recriminazioni che possiamo riscontrare nella relazione sapendo che la sua insufficienza, può essere denunciata, rifiutata in ogni momento e che il patto si potrebbe ritrovare così sciolto. [….]
Dopo aver abbordato le tre categorie che fissano l’identificazione di ognuno, Reale, Simbolico e Immaginario, arriviamo alla quarta, l’identificazione caratterizzata dal sintomo, vale a dire il tentativo di alleggerirsi di questo compito legato all’identificazione sessuale.
Tutto ciò che la psicanalisi ha potuto mostrare riguardo all’organizzazione della nevrosi illustra, beninteso, in che modo questo strano animale umano tenti di difendersi in tutti i modi contro il compito legato all’identificazione sessuale.
….Sviluppare ( quest’affermazione) significherebbe aprire il capitolo delle nevrosi, ossessive, isteriche, fobiche, tutte caratterizzate dalla difesa contro l’identità sessuale e il compito da realizzare.
In questo contesto […..]alle vecchie parole d’ordine rivoluzionarie “ Ad ognuno secondo i suoi bisogni” si sono sostituite, in maniera inedita, quelle (che recitano): “ Ad ognuno secondo i propri desideri”, il che è completamente diverso.
“ Ad ognuno secondo i propri desideri” rompe, sfida il compito che ho appena evocato e che è l’identificazione maschile o femminile, che deve compiersi nel matrimonio e nella fecondità mettendo, direi, il coperchio sui propri desideri o secondo il modo borghese tradizionale, vivendoli in modo laterale e più o meno nascosto.
Ed ecco che appaiono queste parole d’ordine che affermano il diritto, per ogni individuo, di operare, di vivere pubblicamente secondo il proprio fantasma…
Gli effetti di queste parole d’ordine […]sono immediati ed hanno delle ripercussioni, delle conseguenze che viviamo quotidianamente e che evidentemente toccano non solo la libertà che ci si è presa rispetto al dovere di fecondità ma che ormai toccano anche la libertà nei confronti dell’identità sessuale di cui ho appena ricordato i quattro tratti costitutivi: Reale, Simbolico, Immaginario e sintomatico.
[….A questo punto Melman parla dei transessuali come di coloro che hanno portato alle ultime conseguenze queste parole d’ordine ]
Dunque queste parole d’ordine: “ a ciascuno secondo i propri desideri” trovano posto in una rivendicazione che è anche politica, la rivendicazione dell’eguaglianza. Non mi soffermo su questo ma è sorprendente che la nozione di giustizia vada insieme a quella di uguaglianza, che ha un’antica tradizione.
Innanzitutto sappiamo benissimo che l’eguaglianza non si è mai realizzata da nessuna parte, in nessuna delle esperienze storiche che ci sono state tramandate e questo senza dubbio perché ci sono ostacoli indipendenti dalla volontà dei partner per cui l’eguaglianza resta sempre dell’ordine del sogno. In ogni caso questo non impedisce in nessun modo che questa parola d’ordine si sia iscritta nel campo del politico con la conseguenza, che non è una conseguenza qualsiasi, che l’eguaglianza sembra venirsi iscrivere obbligatoriamente come la distribuzione generale di un tratto maschile.
Dopo tutto, non vedo perché debba essere scelto per forza questo tratto come indice dell’eguaglianza che dovrebbe essere resa generale….
Perché non potrebbe essere un tratto femminile? Sarebbe facile mostrare che dal punto di vista della qualità non è certo inferiore a -e meno importante del- tratto maschile!
In ogni caso sembra che uguaglianza voglia dire questo.
Per questo ho parlato di parità nel mondo industriale, evidentemente è la grande rivendicazione nell’ambito del lavoro un trattamento egualitario degli uomini e delle donne, a partire da una giustificazione che è ben reale, quella del salario più basso delle donne. Una rivendicazione che, beninteso, è del tutto legittima, ma che si estende ben al di là. Questo ha oggi delle conseguenze molto sorprendenti sul destino di molte giovani donne e fa sì che la loro realizzazione sociale preceda quella individuale e coniugale.
Per parte mia sono molto sensibile al fatto che tante giovani donne, ingaggiate in carriere professionali, abbiano la più grande reticenza, la più grande resistenza- con grande disperazione delle loro famiglie- a ingaggiarsi in una vita privata che evidentemente le renderebbe inferiori sul piano della loro riuscita sociale.
Inversamente, o simmetricamente, i tanti giovani uomini che fanno carriera nel mondo degli affari hanno la tendenza a voler commercializzare le loro relazioni sessuali per non subire il costo psicologico, ma direi anche materiale, fisico o finanziario, e trovano più “economico” commercializzare le loro relazioni sessuali che metter in piedi una convivenza.
Queste modalità si collocano in una modificazione che definirei essenziale dell’organizzazione del rapporto fra i sessi vale a dire il trionfo dell’eguaglianza, il fatto di mettere l’uno e l’altra sullo stesso piano, nello stesso territorio.
Noi proveniamo da un’area culturale in cui una donna si distingueva per la sua alterità, per il fatto che introduceva nel “mondo grigio ed uniforme degli uomini”, il tratto di essere non solo un’estranea ma di essere “altra”. E per il fatto che reclamava quest’alterità con tutta l’importanza che questa dimensione può avere nell’esercizio del pensiero.
Il nostro pensiero, come sapete da Platone in avanti, ha la tendenza ad omogeneizzarsi, a passare dallo stesso allo stesso. E’ un’antica rivendicazione della nostra civiltà quella di voler omogeneizzare tutto, cioè funzionare nell’”omo”.
Ebbene, nella nostra organizzazione culturale una donna teneva al suo charme dovuto al fatto di essere irriducibilmente Altra, vale a dire in parte di questo mondo, in parte di un aldilà, di un altrove, di avere al tempo stesso un’aspetto certo temibile…. ma anche enigmatico, intrigante etc.
In ogni caso questo faceva sì che lei non si rifaceva allo stesso tipo di ordine del suo compagno.
Invece ecco che, col progresso culturale che viviamo- e utilizzo questo termine “progresso” per designare ciò che viene prima e dopo, ciò che succede a ciò che c’era prima- ebbene oggi siamo su un piano di uguaglianza che è alla fonte del rapporto di relazione, di tipi di relazioni del tutto originali, nuovi, che talvolta rendono i matrimoni simili a delle associazioni, ad amicizie di associati. Voglio dire: si dividono le spese, gli incarichi, i compiti etc.
[….]In questa modificazione radicale [….] ci sono molti meno inconvenienti se una donna occupa una posizione maschile e, nell’esercitarla, dà prova di molta più libertà e di autorità del suo compagno maschio. Le ragioni di questo sono di tipo strutturale: se il suo compagno maschio è legato al fatto che un certo ordine sia stabilito e rispettato, una donna che viene ad occupare la posizione maschile, invece, può benissimo testimoniare che lei non ne è affatto serva.
Ci sono molti esempi nella storia di donne – che hanno occupato posti direttivi dello Stato, ad esempio, o a livello d’impresa, che erano riservati agli uomini- che hanno dimostrato una virilità superiore, molto più decisiva e apparentemente più disinvolta di colui che occupava prima lo stesso posto….
Sono convinto di non dire niente di sorprendente perchè conosciamo le tante situazioni familiari in cui questo avviene quotidianamente. Davvero dovremmo essere rimasti legati ad una produzione d’immagini da bambini, desueta, da letteratura rosa – non so quale- per non essere sensibili su questo punto.
Tanto che beninteso c’è oggi un movimento di femminismo che conosciamo e che riguarda il « gender »che, ricorda, direi con un certo fondamento, che la funzione maschile non è mai così ben assunta, immaginariamente ma anche realmente che quando è tenuta …da una donna.
[….]
In altri termini non c’è più alcun rapporto con le identificazioni maschili e femminili che ho ricordato prima. (Ad esempio non c’è più) un tipo di donna la cui identità sarebbe caratterizzata dall’estrazione radicale della nostra speculazione ordinaria che riguarda l’istanza a cui si riferiscono il sesso maschile e il sesso femminile.
[…]
Su questi fenomeni, su questi sconvolgimenti, abbiamo dei giudizi d’ordine morale da dare ?
E se sì, supportati da quale referente ?
Secondo : questi movimenti sono vivibili nella misura in cui non sono utopistici ma si sostengono per possibilità della struttura ; oppure no ?
Se si ritiene che non lo siano ( vivibili?)-io direi che si tratta di utopie che forzano ciò che la struttura permette-[….]dobbiamo comportarci come difensori della struttura, vale a dire di ciò che è possibile, di ciò che si può e di ciò che non si può?
Infine, terza considerazione fra le altre ma che si potrebbe considerare edonista: le parole d’ordine “ A ciascuno secondo il proprio desiderio” esacerbano un individualismo che non si vede come potrebbe accordarsi con un partner quale che sia. Fosse anche somigliantissimo. Peraltro vivere con la propria immagine allo specchio è difficilmente tollerabile.
Se poi fosse invece differente romperebbe il patto perché danneggerebbe l’affermazione che ognuno ha il diritto di vivere secondo il proprio desiderio. Lo negherebbe, direbbe: “ Bisogna che tu ti adatti al mio, al mio personale desiderio. [……]
Viviamo un momento interessante. Avere un’opinione, un punto di vista più o meno corretto su queste questioni fa parte dell’elaborazione in cui vi impegnate. Grazie per la vostra attenzione.
Conferenza tenuta il 14 maggio 2008 per il ciclo “ A che punto siamo con l’identità sessuale?” alla Maison de l’Amerique Latine a Parigi
Marilena De Luca – “Scegli il chirurgo plastico che abbia il tuo stesso gusto estetico”
“SCEGLI IL CHIRURGO PLASTICO CHE ABBIA IL TUO STESSO GUSTO ESTETICO”
Questa frase propaganda sul web la chirurgia estetica come rimedio per “ristabilire l’equilibrio perduto (val la pena sottolineare il significante perduto) tra corpo e mente”.
Pare ben esemplificativa di una cultura che tende a promettere il superamento dell’impossibile. Quali effetti può produrre nel rapporto con l’immagine del corpo l’introduzione di tecnologie adeguate a promettere di trasformare il corpo naturale in un corpo “come dio comanda”?
Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 la cosiddetta “rivoluzione sessuale” e la rivendicazione di uno status paritario per l’uomo e per la donna è sembrata scivolare sulla ricerca dell’annullamento delle differenze anatomiche. All’idealizzazione di un immagine corporea femminile androgina, faceva da contraltare la proposta della femminilizzazione dell’immagine maschile. Il capo base dell’abbigliamento unisex, i “jeans”, spesso rendevano difficile discriminare il sesso dei componenti di una coppia vista di spalle. Non a caso la moda insisteva per entrambi i sessi sulla valorizzazione dei glutei, forse la parte corporea che meno si presta a “marcare” la differenza.
La neutralizzazione invadeva anche il linguaggio con un uso inflazionato del termine generico “persona”, che permane tuttora, anche per definire il/la partner di coppia, annullando nel discorso anche la differenza tra scelta omo o eterosessuale. Le avanguardie femministe rivendicavano una “specificità” femminile, spingendosi sul piano simbolico della valorizzazione di una cultura e storia al femminile, ma prevaleva in ambiti più vasti il più semplicistico annullamento delle differenze sul piano dell’immagine.
Oggi, per certi aspetti, permane un fenomeno simile di neutralizzazione, ma contemporaneamente sembra di assistere ad un’operazione opposta a quella di minimizzazione delle differenze anatomiche. Anche senza tirare in ballo il ricorso alla chirurgia estetica, le donne, se non si comprimono più in bustini mozzafiato, ricorrono a “push-up” per seni e glutei e molti uomini ad attrezzi ginnici e metabolizzanti per ottenere una muscolatura ipertrofica.
Il ricorso al chirurgo meriterebbe poi un complesso discorso a parte, che potrebbe, per certi aspetti, allontanarci dal tema della sessualità, in quanto, soprattutto se pensiamo alla chirurgia bariatrica, non si tratta più solo di qualcosa che modifica l’immagine, ma di qualcosa che va ad incidere profondamente sul reale del corpo, costringendo ad incontrare nel reale il limite ad un più di godere misconosciuto nel simbolico.
Certamente comunque le conquiste tecnologiche dalla cosmetica alla chirurgia fanno sembrare a portata di mano quegli elisir di “bellezza ed eterna giovinezza” che nella letteratura erano la contropartita di patti con il diavolo. La ricerca di esse non è cosa nuova e Lacan nel seminario sull’etica ci aiuterà a cogliere da dove nasce il nostro bisogno di “bello”.
Per ora limitiamoci a qualcosa della questione del rapporto con il corpo nel mondo attuale.
Lacan, con il rigore che gli è proprio, situa il corpo nei registri dell’immaginario, del simbolico e del reale e dedica molta attenzione alla costituzione dell’immagine del corpo come totalità correlativa alla nascita dell’Io, che ha a che fare con la questione dell’identificazione. Identificarsi è in ultima analisi riconoscersi in un significante. Ma il carattere proprio del significante consiste nella differenza: notte si definisce per differenza da giorno, uomo da donna. Lacan va oltre Saussure sottolineando che un significante si differenzia anche da se stesso, per esempio possiamo dire “sono donna, ma non la donna che credi”.
Ciò che definisce il significante “uomo” non è un’essenza virile, dipende dal suo rapporto col significante “donna” (e viceversa). Così la questione che si pone per l’uomo è di fare-uomo, “sembiante di uomo”, cosa ben diversa dal “fare l’uomo”. Il sembiante costituisce per Lacan la dimensione di ciò che appare, che non significa falsa apparenza, pura immagine, ma anzi ci dice Lacan: “il sembiante che si dà per ciò che è, è la funzione primaria della verità”, è, se mi si concede la metafora, l’ombra della verità, che non si può che adombrare. “Fare-donna”, sembiante di donna, anche qui profondamente diverso dal “fare la donna” è certamente più complesso come ben sappiamo, dal momento che il godimento femminile è anche, ma non solo riducibile ad un godimento fallico solidale con un sembiante.
“Fare-donna” ha in qualche modo a che fare con la presentificazione, credo più che con la rappresentazione che rimanda al registro immaginario, della mancanza e ben sappiamo come, universalmente nello spazio e nel tempo, tale presentificazione sia stata lungi dall’essere letta come “memento” della condizione umana e “alterità” non riducibile, ma piuttosto decifrata, nei termini di una cultura esclusivamente fallica, come inferiorità “naturale”, con tutto il seguito di oppressione e rivendicazione che la cosa comporta.
La questione che mi propongo di provare ad articolare è dunque: in un tempo di prevalenza dell’immaginario e di disponibilità di mezzi quasi illimitati per plasmare l’immagine assistiamo al rischio che il sembiante venga confuso con l’immagine? Che il fare-donna collassi sempre più sul “fare la donna” e il fare-uomo sul “fare l’uomo” (pensiamo anche al lavoro sulla collera di cui ci parla G. Pena Alfaro)? A corollario di ciò si potrebbe anche mettere in evidenza un effetto di sostanziale adolescentizzazione degli adulti, che non sarebbe pura imitazione di ciò che i giovani fanno al corpo (piercing, tatuaggi, etc…) per affermarne l’appropriazione rispetto alla madre che se ne occupava, ma vera difficoltà a fare i conti con esso, nelle sue dimensioni di “alterità virtuale” e limite.
Marilena De Luca
Torino 05.01.2014
Marisa Fiumanò – La violenza come soluzione al «non-rapporto» sessuale
Abbiamo usato questo neologismo crudo, femminicidio, per entrare senza mezzi termini nella questione della violenza sulle donne oggi. Perché, non è inutile ricordarlo, la questione non è nuova. Oggi si pone in termini diversi: le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, soprattutto il diritto alla parola, alla parola pubblica, Da questo diritto, e dalla consapevolezza di averlo, derivano tutti gli altri. Dice a ragione Alina Marazzi nel suo articolo su «Il Sole 24 ore» di domenica scorsa, che la violenza sulle donne è una questione di linguaggio, di accesso al linguaggio e della libertà di usarlo. Altre e altri diranno meglio di me le articolazioni e le conseguenze di questo diritto: il ventaglio di competenze che abbiamo riunito qui oggi mi sembra notevole, dire quasi esaustivo.
Che cosa posso dire io, in quanto psicoanalista?
Mi capita di ricevere uomini violenti. Violenti nel senso dell’azione, uomini cui è capitato di picchiare una donna, ad esempio, o uomini che urlano, inveiscono, bestemmiano, insultano; e che non sono meno violenti dei primi. In genere non è questa però la ragione per cui chiedono una cura. Eppure la loro violenza è gravida di effetti. Un bambino, una donna, ogni essere umano può essere più sensibile alla violenza verbale che allo schiaffo. La violenza verbale però lascia tracce solo nell’anima, nessun livido sul corpo e non è passibile di denuncia. Credo che le donne conoscano bene questo tipo di violenza. Non tutte, ma certamente molte l’hanno conosciuta, magari solo occasionalmente, in un rapporto di coppia. Voglio dire con questo che la violenza maschile, nelle sue diverse sfaccettature e gradi di gravità, è un modo piuttosto comune e frequente da parte degli uomini di accostare le donne.
Credo che sia importante sottolineare la frequenza della componente violenta nei rapporti fra uomini e donne perché è la soluzione che alcuni uomini trovano per superare il solco che li separa dalle donne. Questo solco, che segna un diverso territorio di appartenenza, le rende ai loro occhi incomprensibili, estranee, misteriose, abitanti di una terra straniera.
La violenza, fisica e verbale, è un modo, ovviamente del tutto fallimentare, di annullare l’alterità delle donne, di renderle disponibili, mansuete, a portata d’uso e di mano.
Di uomini curiosi delle donne, disponibili ad ascoltarle, a proteggerle, a prendersene cura, non ce ne sono poi tanti.
Se ci fossero, se ci sono, sarebbero, sono, uomini in pace con il proprio sesso, con la propria funzione, uomini risolti sul piano affettivo e sociale. Uomini in ordine col proprio desiderio in un mondo che però è disordinato e precario, in cui la posizione maschile è difficile da definire e da occupare.
La risposta a questo disordine per fortuna non è sempre la violenza ma possiamo considerare la violenza una delle risposte, una delle reazioni.
La violenza sulle donne non è un problema specifico del nostro tempo: le donne sono sempre state attaccate in quanto incarnazione per eccellenza della diversità, Certamente però oggi la violenza ha tinte particolari. Nasce da una posizione maschile fragile e arrogante al tempo stesso e l’una e l’altra, fragilità ed arroganza, hanno a che fare con una mutazione sociale in cui le referenze tradizionali sono “evaporate”. Lacan dice che la funzione paterna è evaporata, che non possiamo più contare su questa funzione centrale ordinatrice e pacificatrice e che questo produce disordine nel mondo.
Così, anche se possiamo chiamare femminicidio il mandare delle presunte streghe al rogo nel Medio Evo, anche se la paura dell’alterità della donna è una costante nella storia, il fenomeno si innestava allora in una cultura molto diversa da quella di oggi.
“Gli uomini e le donne s’intendono, s’intendono urlare” cito Lacan a braccio. Vale a dire che in ogni epoca, ma in un contesto diverso, continua a insistere un “impossibile”, un incolmabile nel rapporto fra i sessi. In questo la violenza ha le sue radici.
Femminicidio / matricidio
È un fatto noto che la violenza sulle donne, nella maggior parte dei casi, avviene all’interno di coppie stabili o quando un legame affettivo si è già modellato sui fantasmi dei due partner.
Come si può prendere distanza dalla violenza di un uomo amato? Come distinguere, come ci ha mostrato il film che abbiamo appena visto (Ti do i miei occhi di Iciar Bollain), l’erotismo dalla violenza? Come riconoscere la differenza tra il desiderio e una pulsione selvaggia di possesso e di distruzione?
A questo proposito si parla spesso di masochismo delle donne o anche, più cautamente, di credulità amorosa; masochismo e credulità che persiterebbero anche quando i fatti smentiscono spudoratamente la credibilità dell’uomo.
Io non credo però che si tratti di masochismo, né che le donne abbiano tendenze masochiste. Credo invece, ed è un’ipotesi che avanzo, che la difficoltà delle donne a staccarsi da partner violenti, sia da ricercare nel legame che hanno con lui. Intendo nel legame erotico.
Per le donne la sessualità è, anche oggi, traumatica. Lo è per ragioni di struttura. L’ingresso delle donne nella sessualità avviene in maniera traumatica perché è, in una certa misura, estranea al sesso cui appartengono. In molte culture si cerca di aggirare con vari espedienti la riluttanza delle donne all’esperienza della prima notte di nozze. Ad esempio facendole sverginare da un uomo anziano, così che l’ostilità della donna si rivolga verso di lui.
C’è una sola libido, diceva Freud, è maschile. E aggiungeva che alcune donne non riuscivano a raggiungere il piacere con partner diversi dal primo: nella Vienna del primo Novecento il primo marito. Il motivo era che così loro gli restavano fedeli. La fedeltà erotica di una donna, anche oggi, può mantenersi molto a lungo, anche dopo la fine di una relazione. Tanto più se quella relazione ha dei tratti passionali, come avviene di frequente nel caso di relazioni violente.
Le donne restano fedeli all’uomo cui hanno permesso l’accesso al proprio corpo, cui hanno consentito di “traumatizzarle”. Paradossalmente, gli uomini violenti accusano le donne esattamente del contrario: di cercare altri uomini, di essere delle puttane, di volersi esibire ecc. come abbiamo visto nel film.
In realtà si tratta di fantasie maschili: nell’immaginario dei violenti incombe l’ombra di un fantomatico altro uomo, rispetto al quale si sentono inadeguati, inferiori; è un’ombra omosessuale che scatena il delirio di violenza.
Dunque le donne non sono affatto masochiste, solo bizzarramente fedeli; gli uomini non sono innamorati ma insicuri e in balia di pulsioni primitive e paranoiche.
Ci sono anche casi in cui la violenza o l’omicidio non riguardano tanto la donna quanto la madre. Non intendo tanto la madre reale ma una donna in posizione materna. Un amico e collega belga, Jean-Pierre Lebrun, ha scritto un libro sull’attualità del matricidio. Si è appoggiato per le sue tesi sulla trilogia di Eschilo, sulla vicenda di Oreste. Chi è questo personaggio che uccide la madre? E perché? Forse il femminicidio riguarda le donne anche nel loro essere madri? Forse questi uomini senza padre vogliono vendicare, come Oreste, la morte del padre voluta dalla moglie? Per questo ucciderebbero le donne?
È un fatto che molte donne sono oggetto di violenza sotto gli occhi dei loro figli. Anche su questo credo valga la pena di interrogarci. La tragedia di Eschilo ci dice che questo crimine, il matricidio, è antico; oggi appare però insensato, fuori dai canoni della tragedia, privo di ritualità e senza logica. Basta leggere i resoconti delle sedute di riabilitazione in carcere di uomini condannati per violenza: non sanno fornire un perché del loro gesto che non sia un’accusa rivolta alle donne. Non sanno andare più lontano. O più vicino. Tranne eccezioni, sono incapaci di assumere l’atto che pure hanno commesso, come dovrebbe saper fare un uomo.
Ma, come si può essere uomini oggi?
Forse la violenza maschile è un tentativo, balordo ed esacrabile, di trovare risposta a questa domanda.
Relazione pronunciata a Milano, in Casa della Cultura, il 29 novembre 2013,
in occasione di un incontro su “Il femminicidio”
Jean Paul Hiltenbrand La rimozione e il sessuale
Il mio intento non è solo quello di descrivervi come Freud nel 1915 ha trattato la questione della rimozione. Cerco di tracciare per voi le vie metaforiche e metonimiche per aprire alla questione nella nostra modernità, permetterci forse di darne qualche linea di lettura e indicare i cambiamenti legati alla nostra cultura.
Nel primo incontro che abbiamo avuto questo venerdì avevo presentato molto rapidamente la rimozione, quella della nostra vita culturale. Vi avevo mostrato l’apparente paradosso della liberazione dei nostri costumi sessuali e della legge sulle molestie sessuali. Si direbbe che evolviamo verso una maggiore libertà, ed ecco una legge che ci impedisce di esercitarla e quindi ci obbliga a rimuovere ; questa legge incoraggia la rimozione.
Non critico questa legge, semplicemente segnalo il paradosso. Ebbene questa legge mostra indirettamente che la rimozione prosegue ma con altre modalità . In verità si tratta della rimozione del nostro desiderio sessuale. Se ad esempio voglio fare delle proposte alla mia segretaria nel luogo di lavoro bisogna che faccia un esercizio di alta negoziazione.
Questa legge ci mostra dunque senplicemente che la rimozione funziona in un altro modo e che perciò dobbiamo porci la questione della versione moderna della rimozione : posso fare quello che voglio, acquistare materiale in un sexi shop, apparentemente la mia sessualità è libera.
Possiamo dire che la modernità è caratterizzata dal declino del Nome del Padre, vale a dire che non c’è più Padre-padrone, è stato molto detto e su questo non c’è più mistero, ma ciò che è dimenticato a proposito del cosiddetto « declino del Nome del Padre », è che c’è anche declino della funzione fallica. Come si sente dire spesso : « non ci sono più uomini », vale a dire che non ci sono più uomini che possano testimoniare di questa logica introdotta dalla funzione falica.
C’è qui con noi il nostro amico Christian Rey, che ha organizzato recentemente un convegno sul tema dell’autorità. Vi ricordo con lui che nella modernità il significante maitre S1 non ha più posto. Tutte le ideologie organizzate da questo significante–maitre sono crollate, bisogna cambiare ideologia.
Ho nel cassetto una lettera di Lacan inviata a Serge Leclaire in cui Lacan scriveva : « Carissimo, le vieto di fare il seminario di cui Christian Simatos ( all’epoca segretario della Scuola di Lacan), mi ha informato. Lettera firmata con data. Vi rendete conto? Oggi una lettera come questa non si può più scrivere altrimenti si passa per essere un dittatore oltranzista, eccessivo. Il management moderno nelle imprese rende perfettamente conto di quest’impossibilità di affermare un’autorità senza prova e senza dimostrazione. Oggi il management utilizza la persuasione. Oppure la pressione con salari, premi etc.
Per noi è importante fare queste constatazioni e cercare di leggerne le conseguenze attraverso la rimozione.
Il declino del Nome del Padre ha prima di tutto come conseguenza la cancellazione del carattere prevalente del desiderio. Una volta bisognava sottolineare il proprio desiderio altrimenti vi si diceva che eravate inconsistenti dato che la dimensione del desiderio è costituita dalla funzione fallica. Non abbiamo più un superio paterno che ci imponga alcuni doveri come la cortesia, la gentilezza, di lavorare fino alla fine della giornata. Perché allora questa legge sulle molestie sessuali ? Perché se la sessualità era regolata dalla castrazione e se questa regolazione non funziona più perché la castrazione era legata al Nome del Padre e alla funzione fallica, se non avete più il vostro “coso”, la vostra “codina”, se questa funzione non è più importante, la vostra vita non è più dominata dalla forbice e quindi il sesso perde la sua importanza. Così avviene, ad esempio, in colui che si droga.
Se non c’è più Nome del Padre, non c’é più castrazione, non c’è più funzione fallica, non siamo più nella sessualità e a questo punto il soggetto è affidato alla sua pura genitalità, alle pulsioni non rimosse. Non è il passaggio dalla sessualità alla genitalità ma è la genitalità selvaggia.
Capite quindi la ragione di questa legge paradossale sulle molestie sessuali, quella di porre un limite a una genitalità pulsionale senza limiti. Il soggetto moderno, se non è più limitato da ciò che ho descritto, è dominato da ideali di godimento, godimenti senza limiti e immediati. Dunque c’è rimozione del sessuale, a vantaggio della genitalità. E’ quello che ci ha mostrato il Maggio ‘68 con il suo slogan « vietato vietare », la liberazione della pulsione che non è più rimossa. Allora è la sessualità che è rimossa a profitto della genitalità.
Quello che succede nella nostra cultura attuale è una proposta di genitalità senza vergogna. Lo sentiamo nella clinica dei bambini : il sessuale è rimosso ma non il genitale. Questo è legato al declino della struttura della famiglia. In Italia è meno sensibile ma in Francia si può dire che non c’è più il modello tradizionale di famiglia, le modalità di rimozione non sono più le stesse. Ci sono famiglie in cui tutti girano nudi per casa e spesso succede che la bambina ad esempio non sopporti questo modo di vivere in cui sembra che la rimozione non esista più. In questa pratica di nudismo a casa il corpo non è più sottolineato dalla differenza, vale a dire che un uomo e una donna sono la stessa cosa. Vi rendete conto ? Passeggiate nudi e non rischiate più di incontrare il desiderio dell’Altro. Ma che mondo è ?
Dunque la rimozione continua ma nel più totale totale smarrimento riguardo a ciò che concerne le strade del sessuale. I giovani non sanno più dov’è il luogo del sessuale. Nelle famiglie che circolano nude ciò che è rimosso è il luogo del sessuale perché la camera dei genitori è accessibile a tutti, non importa quando.
Trascrizione della parte finale del seminario sulla Rimozione tenuto a Milano in Casa della Cultura il 17 e 19 Maggio 2013. Non rivista dall’autore.
rinviato il Convegno sull’autismo del 16 dicembre a Roma
Convegno organizzato dalla Provincia di Roma e dall’ALI-in-Italia dal tema: LA PERSONA CON AUTISMO E L’ALTRO. Parteciperà ai lavori la dott.ssa Marie-Christine Laznik che lavora a Parigi presso il Centro Alfred Binet con un’equipe di neuropsichiatri infantili, pediatri e professionisti della prima infanzia per la prevenzione e l’individuazione precocissima di segni di autismo, nei primi due anni di vita.
Lavorando sui filmati familiari che permettono di osservare i bebè futuri autistici sin dalle loro prime ore di vita e avvalendosi di uno scambio fecondo con i ricercatori del centro Stella Maris di Pisa – scambio che ha permesso l’incontro produttivo tra psicanalisi e scienze neurobiologiche – Marie-Christine Laznik si è fino ad oggi molto adoperata anche nella formazione, per sensibilizzare pediatri e medici di famiglia, assistenti per l’infanzia e insegnanti della Scuola dell’Infanzia.
La proposta del convegno si realizza entro un confronto pluridisciplinare con professionisti di varia provenienza, neuropsichiatri, pediatri, insegnanti, educatori, funzionari della pubblica amministrazione e associazioni dei familiari.